
29 Giu Atti di nascita: in dialogo con Claudia Di Palma
A cura di Francesca Grispello
Come veniamo al mondo
rigettati dall’onda.
Come la doglia ci spinge
fino a riva
e prima il grido poi la gioia
dell’approdo
La poesia di rima in riva ci mette al mondo, con organi e occhi nuovi.
Sembra incredibile talvolta che un po’ di inchiostro e una manciata di lettere possano sempre riposizionare lo spazio e il tempo in cui vivi, o credi di vivere.
Ho conosciuto la scrittura di Claudia Di Palma per risonanze, senza un metodo scientifico, Atti di Nascita (Minerva Edizioni) è un testo piccino, ma denso di luce, con un impianto teoretico vibrante che continua a rimandare e a riallacciare.
Ed è così che poi ci si sente scovati dalla poesia.
Atti di nascita rivela già dal titolo un “è”, non qualcosa che spera, nessun messianesimo, ma la più creaturale e vitali delle alchimie: trasformare la potenza in atto. Quasi a volerci dire, che se possiamo morire una volta sola, possiamo rinascere continuamente. Il volume si apre con cinque domande, dove troviamo assunti germinativi forti, una base teoretica solida eppure aperta: i nomi sono strumenti per cercare dio, scrivere è come organizzare una festa, la poesia è un corpo…. Dio e la condizione umana, di creatura appunto, dove la parola viene sottratta all’ordine del tempo e mescolata impastata di mondo e pulsazioni per generare, creare, per lasciarsi invadere dalla mancanza di dio.
Aspiravo alla grazia:
un involucro superfluo,
il trucco sul volto di una donna,
il rossetto sbavato sulle labbra.
Così immaginavo Dio, così lo sognavo.
E la mia preghiera era guardare,
provare a vestirmi sul nulla,
provare a compormi, e poi
raccogliere gli avanzi,
decifrare il mio nome.
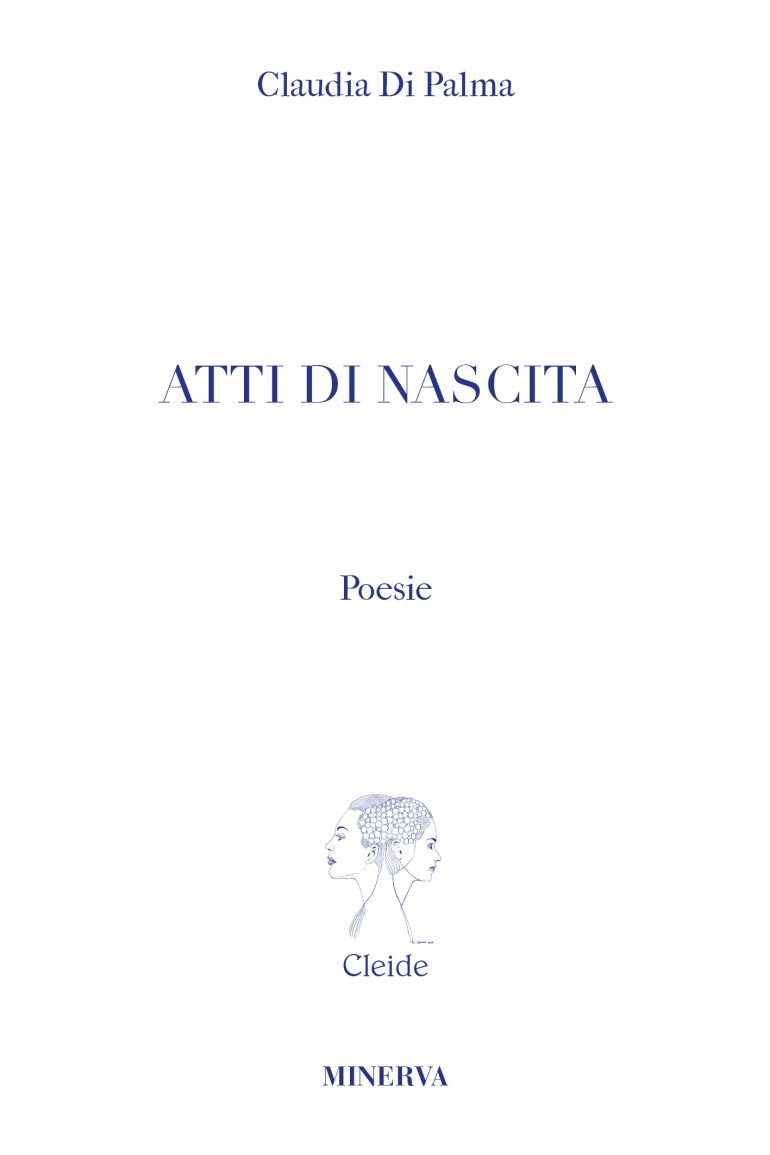
Claudia, come e quando hai iniziato ad avvicinarti alla poesia e alla scrittura?
La necessità di scrivere nasce proprio da una mancanza, una mancanza di terra, di casa. Ho iniziato a scrivere per rimarginare la ferita di un esilio forzato, dovuto ai continui trasferimenti della mia famiglia. Così all’età di 9 anni ho scritto la prima pagina del mio diario. Poi, molto più tardi, sullo stesso diario ho scritto le prime poesie, quelle confluite nella mia prima raccolta, Altissima miseria. Penso che tuttora la poesia sia per me una sorta di dimora, una casa parlante, che si affaccia sull’altro, cercando di ricucire quell’esilio che ci accomuna tutti, la distanza incolmabile dall’altro, il mistero dell’altro.
Quanto spazio occupano Dio, la scrittura e il corpo nella tua vita? La condizione di creatura umana è una condizione eletta riguardo a Dio oppure è una ferita che rimanda a una mancanza incolmabile? Se le parole “dicono” la distanza da dio, cosa fanno tra gli esseri umani?
Dio è l’Altro per eccellenza, il totalmente Altro, così Altro che si sottrae alla nostra vista e ai nostri sensi. Eppure è proprio ritornando al corpo, che possiamo percepirlo. Non credo che vi sia una separazione tra materia e spirito. Al contrario, penso che l’ascolto del corpo sia in qualche modo l’ascolto di quel Dio, che se esiste, ci appartiene visceralmente. Alla fine, non c’è differenza tra fuori e dentro, tra sé stesso e altro. Cito lo Zhuang-zi, un libro che sto leggendo in questi giorni: “sé stesso è anche l’altro; l’altro è anche sé stesso.”
Quella mancanza (di Dio, dell’altro) è anche una mancanza di sé. Una mancanza che la parola non può colmare. A volte, ho proprio la sensazione opposta: che la parola amplifichi la mancanza. C’è sempre, quando scrivo, l’illusione di un avvicinamento, di un riempimento, e poi, quando rileggo le parole sulla carta, la percezione di un allontanamento, di uno svuotamento. Quello sgomento di non aver fatto niente. Ma che fortuna non dire, non definire, restare con la ferita.
 E l’amore? È distanza o sguardo?
E l’amore? È distanza o sguardo?
Se ti guardo vuol dire che sei distante da me. Se mi fossi vicino, non potrei guardarti. L’amore è la distanza che permette lo sguardo ed è anche lo sguardo sulla distanza.
Copro la nudità per pudore, mi viene il dubbio che non ci sia nulla da vestire, nessun corpo, nessuna rosa. Nessun corpo, nessuna rosa. La parola poetica è mistica. Corpo e rosa cosa hanno in comune?
Domanda difficile. Quella poesia è venuta così, ancora non so perché ho associato “corpo” e “rosa”. Mentre scrivevo “nessun corpo, nessuna rosa”, ho intuito che “corpo” e “rosa” fossero la stessa cosa, ma non saprei dire perché.
Quando penso alla rosa, penso sempre al romanzo di Umberto Eco, Il nome della rosa, il mio primo amore letterario – avevo 12 anni quando l’ho letto la prima volta e l’ho riletto più e più volte, in adolescenza e in età adulta.
“Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus” è stato per me una sorta di mantra. Poi ho cominciato a pensare che potesse valere anche il contrario: Stat nomen… Allora abbiamo rose nude, i nomi sono vestiti che non coprono niente.
Ci resta solo la rosa, solo il corpo, senza nomi.
Ci resta la nudità (di un corpo o di una rosa, fa lo stesso).
Sono ciò che vedo, il volto dove mi incastro.
Devo tenere gli occhi aperti per essere, devo
guardarti incessantemente.
E ancora
I tuoi occhi, incisi nel mio ventre, sono un buon combustibile, ma il tuo sguardo resta a lungo, come la fuliggine.
Cosa è lo sguardo? Cosa vediamo e cosa abbiamo necessità di mostrare?
Lo sguardo è il tentativo di colmare quella mancanza incolmabile, di cui dicevamo prima. Ed è anche l’unica possibilità di mettersi al mondo, di fare davvero un “atto di nascita”. Solo attraverso l’altro posso esistere. Solo nello sguardo – quella frattura tra me e un altro – possiamo esistere entrambi, io e l’altro. Lo sguardo è anche la possibilità di un sovvertimento, di un divenire, per cui alla fine trovo un altro dentro di me (che no, non coincide con l’altro che guardo fuori di me e che comunque mi resta ineffabile). Il “siamo” è forse impossibile, ognuno “è” separatamente dall’altro, ognuno è da solo. Questo è meraviglioso: anche nell’unione, anche nei rapporti di coppia, si resta separati, ognuno con la propria identità. Però l’identità è qualcosa di mutevole, come un vento, o una nuvola che si forma e deforma trasforma grazie all’altro.
Dove trai ispirazione? Persone, luoghi, storia personale? Per essere è necessario un “siamo”?
La poesia nasce dalla necessità di comunicare con questo altro. Sicuramente traggo ispirazione dalla mia storia personale. La poesia che hai citato, per esempio, è una poesia d’amore.
Cosa è per te il femminile? La scrittura “al femminile” ha delle caratteristiche specifiche oppure nella poesia siamo creature senza genere?
Non so cosa sia il femminile – forse anche questo un nome, un vestito che non copre niente, “nessun corpo, nessuna rosa”? Penso che la scrittura “al femminile” abbia delle caratteristiche specifiche, ma non saprei definire quali. Poi non dimentichiamo che ognuno di noi ha un “maschile” e un “femminile”, e quindi il discorso si complica ulteriormente.
Nei tuoi versi – tra ricerca e preghiera – cerchi il tuo nome oppure le sue declinazioni?
Nei miei versi mi cerco, non mi trovo mai. È sempre giocare a nascondino con la parola, cercare di mostrare qualcosa e allo stesso tempo occultarla. Insomma, nella poesia faccio quello che faccio nella vita; anche nella vita gioco a nascondino, cerco di mostrarmi e di nascondermi. Forse facciamo un po’ tutti così.
La parola è uno specchio che allo stesso tempo mostra e nasconde la nostra immagine. E io forse cerco questo specchio inconsistente, che separa mentre unisce, mostra mentre nasconde.
Corpi come pezzi, mezzi, merce, orologio: cos’altro è il corpo? Che rapporto hai con il tuo? Corpi, mondo, rifiuti, respiro: nei tuoi versi si alterna affanno e celebrazione, ricerca di respiro e resa. Quando ci si arrende cosa succede?
Il corpo è tutto. Non esiste altro luogo all’infuori del corpo. Tutto quello che facciamo lo facciamo con il corpo, anche scrivere. E tutto quello che viviamo ci abita, cioè abita il nostro corpo, la nostra psiche. Arrendersi è allora arrendersi al corpo, arrendersi alla vita. E quando ci si arrende succede qualcosa, prima non succede niente. Insomma, la resa è il presupposto perché qualcosa accada, qualsiasi cosa. Ed è così difficile arrendersi davvero.
Se tu dovessi scegliere tra la dimensione dello spazio oppure del tempo, quale tra queste abiti più spesso?
Sicuramente la dimensione dello spazio. La casa, la città, la terra originaria, l’origine imprendibile, la lontananza, l’esilio…
Un libro
Il nome della rosa, l’ho già detto.
Un odore
L’odore di bruciato.
Un luogo
Casa.
Un sapore
Salato.
Un ricordo
Le bellissime conversazioni con il poeta Michele Truglia, che purtoppo ci ha lasciati l’anno scorso.
Un sogno
La vita. La vida es sueño.
Un’immagine
Le gocce di pioggia sul parabrezza.

No Comments