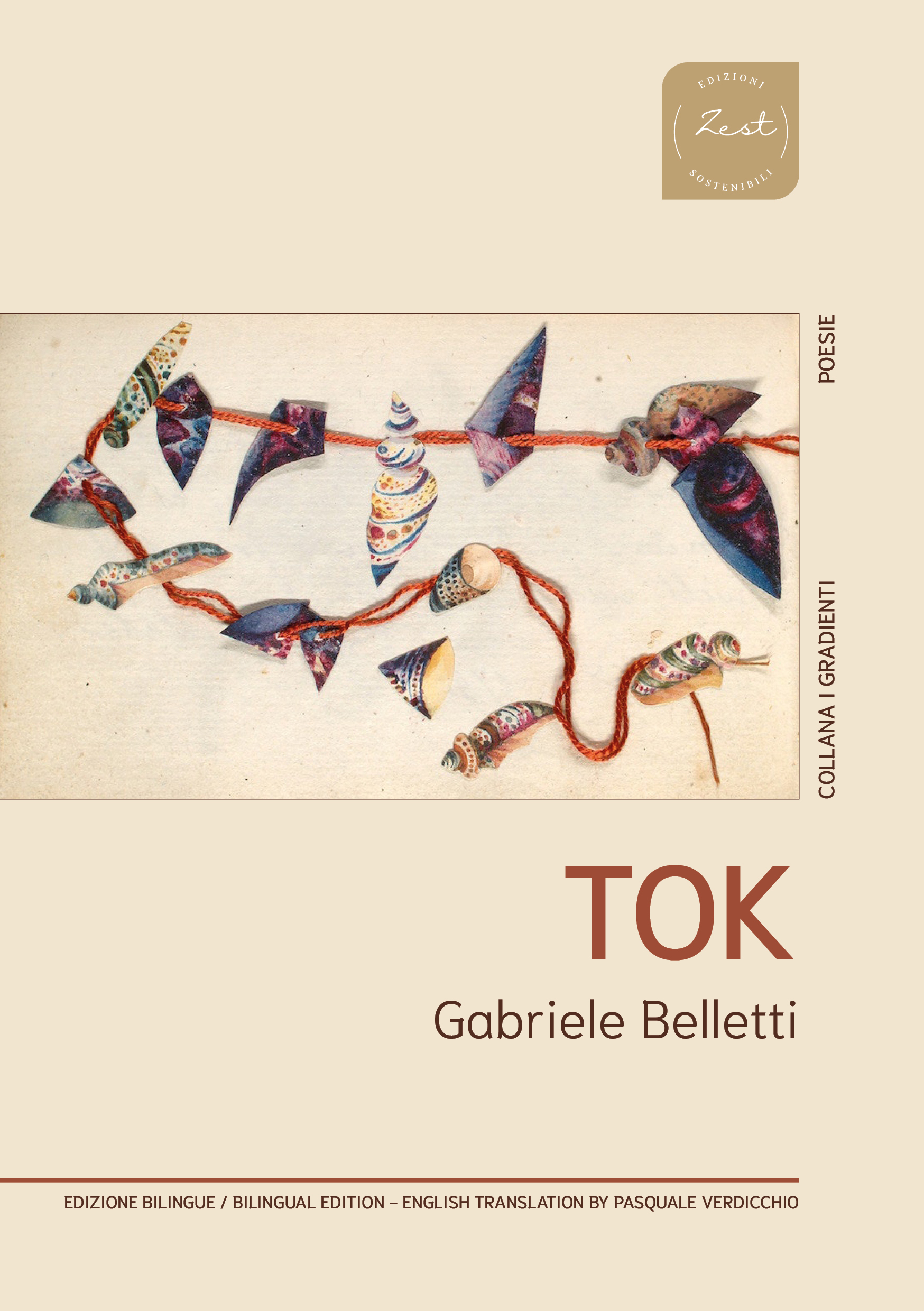
03 Dic “Tok” di Gabriele Belletti: la percezione del vivibile come luogo di salvezza
di Vincenzo Corraro
“La paura si sparge/ – e tuttavia –/ non attecchisce./ Nell’arca, pulsa/ una progenie di fati/ preparati/ per abitare nuovi luoghi.”
Compito essenziale della poesia è scuotere le aspettative, riorganizzare l’esperienza e le percezioni dell’ordinario. Esiste un mondo che abbiamo abitato e lo abbiamo distrutto: abrasioni, distanze, nefandezze di ogni foggia si muovono in superficie e danno la dimensione della nostra solitudine. La parola riacquista così il posto necessario e indispensabile per comprendere l’esperienza e riacciuffare il senso del nostro abitare, nel tentativo di formulare ipotesi che tengano conto dell’inclusione del paesaggio dentro la nostra prospettiva umana (mentale, emotiva, motoria) che può rigenerarsi solo da un perduto linguaggio comune.
Gabriele Belletti esplora proprio questa strada. E lo fa con garbo, capacità visionaria, mettendo al centro della sua poesia il fertile rapporto tra la parola e il mondo che essa evoca attraverso i cardini dell’universale (o del vulnerabile). Procede con giocosa libertà fra i due estremi di uno stesso orizzonte: da un lato seguendo un tenace attaccamento agli elementi essenziali della realtà e dall’altro facendo irrompere nella narrazione la dimensione spaziale del percepito.
La raccolta ha per titolo Tok ed è il primo titolo della neonata casa editrice Edizioni Zest Sostenibili, marchio guidato da Antonia Santopietro che ormai da anni, in rivista e con contributi di divulgazione scientifica, si è distinta per un intenso lavoro di ricerca nel campo delle tematiche ambientali e della sostenibilità, anche in chiave poetica e letteraria.
Proprio nella parola ‘percezione’ si trova la chiave di lettura delle poesie di Belletti. Ci troviamo anzitutto di fronte a testi, il cui approccio alla realtà è definito per frammenti e unità sintetiche che si stagliano sull’alba di un disastro che parrebbe ecologico, “tra scheletri di paesaggi scomparsi”, “cumuli di polvere/ di scordate epoche”, ma forse più esistenziale: “le proiezioni delle cose/ sono diventate le cose.”
Sembra un mondo senza speranza, almeno nelle prime poesie, finché un bambino non entra in scena e scuote l’intero paesaggio amorfo e in stallo che lo ha generato, cominciando a muoversi oltre la desolazione, oltre i pesi del mondo, e attraversa uno spazio che dà ampiezza, struttura e significato alla stessa raccolta poetica.
Tok per i Kaluli, popolazione della Papua Nuova Guinea, vuol dire ‘sentiero’, ‘accesso’. Il termine è preso a prestito dall’antropologo Steven Feld, che in un suo saggio – divenuto un classico in ambito musicologico: Suono e sentimento (1982) – ha investigato, dal punto di vista sonoro, i forti legami esistenti tra l’universo animale, vegetale e umano dei Kaluli. Rigettando le infruttuose categorie occidentali di analisi del suono, Feld arrivò a definire la funzionalità del loro linguaggio, frutto dell’equilibrio tra sapienza culturale degli esecutori e aspettativa degli ascoltatori.
Si diceva dell’approccio. Gabriele Belletti si muove in un modo autentico proprio al servizio dell’ascolto: ancor prima di ogni elaborazione, di ogni sovrastruttura, in Tok l’attenzione è rivolta all’inedito, al non catalogabile, a ciò che abbiamo perduto o a ciò che si trova lontano, dove il paesaggio culturale e l’eco-evoluzione dell’uomo si riappropriano di una dimensione delle origini, epurata da qualsiasi incrostazione umana, che è diventata, per generazioni, autodistruttiva e nociva soprattutto per le altre specie.
La raccolta, che si presenta in una elegante edizione bilingue (le poesie sono tradotte in inglese da Pasquale Verdicchio), ha un incedere narrativo ben marcato; diremmo circolare e di compiutezza formale e di contenuto, in cui ogni singolo componimento della silloge è un tassello della narrazione. L’essenzialità della presenza umana (il bambino che percorre lo spazio-foresta) si dimena in un luogo simbolico come “una fragile speranza”, mentre espatria dai resti di uno scenario apocalittico, alienante e da colpe che non sono sue. E il mondo va delineandosi per frammenti e simmetrie di luce, in una dimensione dello stupore posta in relazione con ciò che va creandosi, con il paesaggio che va naturalizzandosi.
Da qui il riappropriarsi di ogni conoscenza, del “canto/ come fosse il nostro testamento”, di sensazioni, di un mistero che avvolge il visibile, tratteggiato con linee essenziali perché tutto quello che il bambino tocca “unisce le creature/ le fa ascoltare insieme.”
Naturalmente, come in ogni evoluzione, la vita non è mai semplice. Adattamento, crescita, scoperte, apprendimento. La foresta è un luogo carico di simboli, così come i processi umani sono il frutto di una comunità armonica, che trasmette alle generazioni il proprio patrimonio culturale. C’è un debito verso l’ecologia e i principi organizzativi della natura che è dirimente in queste poesie: da un lato la sfuggente dolcezza della bellezza, il canto felice della natura che si fonda su un gioco di costanti interazioni, sovrapposizioni, riverberi tra elementi primari del pianeta (corsi d’acqua, alberi) e elementi atmosferici, uccelli, voci umane; dall’altro l’ignobile mappatura del disastro, considerato come luogo da cui si scappa, governato da “codici e pulsanti”, dove gli uomini “si proteggono dai loro sbagli” e “tutto è rifiuto/ che rifiuto continua a diventare.”
L’accesso nel bosco è in realtà un ritorno, una spazialità recuperata che diventa un “segreto ramoso” di cui il bambino a un certo punto si sente parte. Parte di un sistema culturale che gli strumenti conoscitivi di cui siamo in possesso tendono a considerare una patria perduta, meramente esotica, ingurgitata dalle fauci dello sviluppo. E invece è un ambito esperienziale in cui la linea poetica – o della parola riemersa – comincia a risvegliare istinti e sentimenti e azioni, confini che rappresentano un inizio. Infine codici, su cui impiantare “un altro mondo”.
“Un’isola piena/ di aria antica” circonda questa rinascita e il punto di svolta di questo originalissimo testo, crediamo sia alla fine della Parte Prima, quando la metamorfosi si compie: alberi e uccelli sono un’unica cosa con il “fuggitivo” e la partitura si dilata in un’ampia visione proprio su margini evanescenti e di impressionismo sensoriale:
“Nel cuore del bambino/ ritorna vivo/ il rintocco dell’uccello./ L’albero lo libera – ed è ancora quello –/ nelle arie e nelle membrane/ – come si agitano, pare un vento/ di doglie e di molto rare particelle.”
Molto ben riusciti, nella raccolta, sono ancora gli spostamenti di registro, le dislocazioni del soggetto. È un divenire fluido, molto musicale, in cui l’Io che ogni tanto riaffiora solo per esprimere una presa di distanza e per riconoscersi in una comune esperienza. In etnomusicologia il dato sonoro è sempre collegato agli aspetti comportamentali, ai rapporti e ai bisogni sociali di un popolo, oltreché all’ordine naturale del contesto e alla sua eco-organizzazione.
È su questo ‘patrimonio dell’attesa’ che si amalgama la poesia narrativa di Belletti, con un lessico poetico che intinge nella tradizione, ma ricorrendo a toni prosastici all’interno di una esposizione formale che si intreccia alla leggerezza apparente del verso (breve, sincopato grazie ai ricorrenti enjembements, alle rime interne, al ritmico settenario), o alla resa di un candore infantile e innocente, a una lucidità traspositiva che rende con brio il senso del percepito.
Un mondo sommerso d’altronde si può raccontare solo attraverso i codici della società che lo preserva o simulando i miti che l’alterità riconosce.
Belletti ci riesce benissimo, nell’uno o nell’altro intento. Il risultato è altresì duplice: il tono è sommesso e asciutto per mappare l’esistente; e l’allegoria è disinvolta perché il dichiarato sforzo sperimentale del progetto, maneggiato con perizia, non intacchi la comunicabilità o la brillantezza dei versi.
In tal senso l’estetica del paesaggio diventa l’estetica dell’esperienza umana, che induce a cogliere il riverbero di qualcosa che è già dentro di noi e ci fa sentire “un’unica creatura” – che è poi la sfera che abbatte differenze e steccati, conducendoci al pieno possesso della conoscenza. Alla salvezza.
O all’arca. Che è l’ultimo tratto di sentiero del bambino, dove l’armonia viene saldamente ricreata. Il “segreto ramoso” è diventato un “ventre ramoso/ un’arca sepolta”. Qui le presenze umane sembrano risvegliarsi, mentre gli uccelli, animali dell’innocenza, chiudono l’arca “con limo/ e pezzetti di prato.” Sembra di essere tenuti per mano come in una canzone-capolavoro di Francesco Guccini (Il vecchio e il bambino): il perimetro che si allarga, la favola della rinascita che ha dell’ineffabile, il fragile cammino dell’uomo in mezzo alle incertezze – ci rivela Belletti in Tok – è assediato da una “paura [che] si sparge/ e – tuttavia –/ non attecchisce” (fra i versi più belli della raccolta) e da “un odore salino/ già ornato di nuovi pensieri.”
Tok contiene poesie di luce, che hanno tuttavia una profonda investitura civile. Esplorare le forme che l’umano può assumere, riconoscersi in un universo il cui contrappunto risuona nelle nostre sane relazioni e “nell’anima del luogo” apre all’esigenza di interrogarsi sulle ragioni che vincolano il nostro esistere alle responsabilità. Resistenza e poesia da sempre danno forma all’esistenza. Non è un caso che tra le macerie, tra i “figli delle scorie”, sul finale, ci venga incontro il “poeta morto ammazzato”. Che è un omaggio a Pier Paolo Pasolini: l’accesso alla bellezza è segnato proprio da una delle sue tante taglienti invettive sulla smarrita forma del paesaggio. Che diventa ‘ricordo’ (anche in Belletti), un disegno opaco di epoche andate.
Ai confini della parola e della memoria, “in un giorno lontano nel tempo”, questo ‘passato senza nome’ – per dirla con le parole di Pasolini – ci chiederà conto della nostra appartenenza alla terra.
Gabriele Belletti, Tok, Edizioni Zest Sostenibili (collana I Gradienti), euro 14.00

No Comments