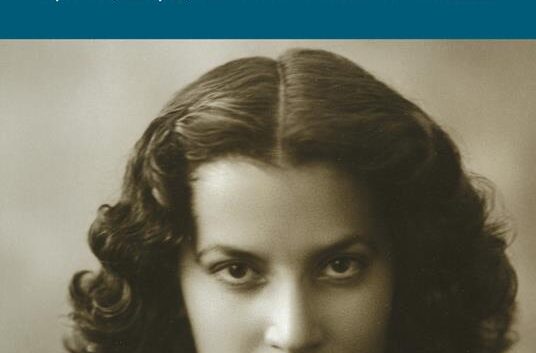
01 Ott E tu, chi sei? Spazio, corpo, visioni in Anna Maria Ortese. In dialogo con Lilia Bellucci
a cura di Ivana Margarese

Come è nato il tuo incontro con Anna Maria Ortese e cosa ha dato avvio alla genesi e alla stesura di questo saggio?
La ricerca ha preso avvio dalla tesi per una terza laurea con Tommaso Pomilio, ovvero Tommaso Ottonieri, scrittore e poeta del gruppo ’93, figlio di Mario Pomilio. In quel lavoro davo centralità a l’Iguana, che mi aveva avvinto in un’operazione continua e quasi ipnotica di rilettura ed analisi.
Vi indagavo un alfabeto della dis-nascita: una volontà di decostruzione di modelli e di rigenerazione culturale e spirituale. Mi interessava coglierne strategie e finalità. L’attenzione per la scrittrice era rinata dalla lettura della sua constatazione di essere una donna «antipatica, aliena, impresentabile» ed «esigente». Solo chi aveva sofferto poteva amarla e riconoscersi nei suoi libri. La mia attenzione si è poi consolidata con gli studi di genere e l’impegno per la valorizzazione di scrittrici fuori canone. Una volta addentratami ne L’Iguana, non ne sono più uscita. Continuo a studiarla.
E tu, chi sei? Spazio, corpo, visioni in Anna Maria Ortese è il titolo del tuo libro. Muoverei da questo “E tu, chi sei?” per concentrarci sul valore che per Ortese hanno l’interpellare e l’ascoltare e per sottolineare come la scrittura di Ortese chiami in causa il lettore, costringendolo alla fatica di spostare il suo punto di vista sempre più verso ciò che non è scontato. “Una letteratura, appunto, di azione e visione, insegnamento, gioia, profezia insieme. Potrei chiamarla, anche, letteratura del coraggio”.
Trovo che queste parole di Ortese in Corpo celeste rendano alla perfezione il suo impegno letterario. Mi piacerebbe una tua riflessione su questo.
Le prime parole del titolo richiamano E tu chi eri? 26 interviste sull’infanzia, una raccolta di voci di scrittori e artisti, pubblicata da Dacia Maraini nel 1998. Per me, ripercorrere il vissuto di Ortese significava cercarne le radici tra le sue esperienze di pensiero e di vita, un risalire indietro a quanto accadeva in lei ancora prima di una narrazione. Per questo, il mio libro racconta momenti della sua vita e delle sue opere, ma sempre impegnandosi nel comprendere dove e come generasse il senso della propria vita e della propria scrittura. Cercavo, senza dubbio, e continuo a cercare il «centro della cattedrale», come direbbe Monica Farnetti. Questo comportava un impegno maggiore, un processo di selezione, che non poteva che nascere da un coinvolgimento forte, da un sentire profondamente le motivazioni dell’altro. In questo modo, la lettura di Ortese non mi lasciava mai ‘indenne’ e si intrecciava con riflessioni sul nostro presente. Percepivo le sue parole feconde e vitali, ancora capaci di risuonare in modo forte. Il mio libro è costellato di domande, che a partire dalle sue parole traduco nella nostra dimensione presente. Di qui, la trasposizione della domanda E tu, chi eri? di Dacia Maraini in un tempo presente, con l’inserzione di una virgola, per creare una pausa di silenzio tra il richiamo all’attenzione e la riflessione sull’essere. Il silenzio è il paesaggio interiore che si crea nell’interiorità, quando si solleva la mente dall’immediato e dall’utile. È una sospensione necessaria, quell’attesa che crea disponibilità all’ascolto e alla reciprocità. “E tu, chi sei?”chiama in causa individualmente, è proprio un fuoriuscire dal libro stampato, un indicare visivamente il lettore che legge le informazioni in copertina. L’ultimo capitolo racchiude alcuni motivi di questo invito, sintetizzando diverse sollecitazioni precedenti, ma proprio perché, come Ortese avrebbe voluto, il lettore non deve rimanere al di fuori del discorso narrativo, ho voluto proporre in un incontro con alcuni studenti un questionario in cui ho raccolto gli interrogativi estrapolati dal mio libro. La lettura deve nascere da domande di senso e ne deve generare altre.
Nel nostro presente, manca il raccontare chi siamo. Eppure, il bisogno è forte. Lo si riconosce nell’uso dei social, dove quel bisogno, però, non è accolto e potenziato dalla letteratura, ma è lasciato alla deriva in un flusso ininterrotto. È frantumato e disperso, svuotato del suo stesso significato, privato di una memoria duratura e rielaborativa, trasformato in un individualismo ridotto a protagonismo e non a relazione anche contro le sue stesse intenzioni. Il bisogno di raccontarsi nasce oggi dal voler sfuggire al meccanismo dell’efficienza e della produttività, all’isolamento e anche all’autodeterminazione, ma finisce snaturato in uno spazio virtuale spersonalizzante e inesorabile. E tu, chi sei? è un invito a recuperare attraverso Ortese il desiderio di apprendere un linguaggio potente e universale oltre il visibile, di rendersi permeabili all’immaginario e alla passione del vivere, di abitare con il corpo spazi di comunità e di cittadinanza universale. E tu, chi sei? è la domanda che il mio libro si propone di lasciare in chi legge, perché di questo abbiamo bisogno oggi: riprenderci la libertà/responsabilità di dire chi siamo e come vogliamo stare al mondo. Ed è un atto di coraggio, indispensabile nella vita e nella letteratura. Ed è prima di tutto, capacità di visione di un oltre.

Anna Maria Ortese è una scrittrice che fa un lavoro interminabile sui suoi testi, cancella e rivede. Cosa ci dice a tuo parere questo su di lei e sul suo scrivere?
E’ lo stesso lavoro interminabile che richiede a chi la legge, con una scrittura che a volte è poco decifrabile e comprensibile. Sto cercando una chiave di lettura differente e penso di pubblicare al termine della mia ricerca un altro volume. In fondo, è lo stesso lavoro interminabile che siamo chiamati a fare su noi stessi. Proviamo a rileggerci, a ricostruire il senso del nostro passaggio in vita, a pensare di lasciarlo in dono per qualcosa o qualcuno? L’inadeguatezza, il dubbio, la fragilità dello scrivere e riscrivere, come del leggere e rileggere, sono anche tracce di un’intelligenza tenace e profonda, mai soddisfatta della superficie delle cose, sempre coraggiosamente aperta ad altro, anche deviando dalle aspettative altrui.
Quella di Anna Maria Ortese è ancora una letteratura di ricerca, che cede poco ai condizionamenti dei numeri delle vendite o alle richieste degli editori, così come cede poco ai condizionamenti di partiti e di chiese. E’ anche una letteratura aperta, che fatica soprattutto nel definire il finale di un romanzo. Mi riferisco alle riscritture de L’Iguana, per esempio. L’ipertrofia della definibilità è un male dei nostri tempi, che inseguono il mito del perfectum, cioè del compiuto e quindi processabile, verificabile, portatore di risultato. Il compiuto è concluso, appunto. Non comporta spostamento d’asse, non valorizza la variazione trasformativa, il rovesciamento di prospettiva. Soprattutto, fa dimenticare il mistero, indecifrabile e impossedibile, che è dentro tutto e tutti. Se lo dimentichiamo, non siamo più in grado di provare il desiderio dell’altro, di altro.
Un paragrafo del tuo saggio si intitola “Corpo d’acqua” e qui fai delle interessanti associazioni con alcune artiste visuali come Astrida Neimanis, Maria Magdalena Capos – Pons e altre. Mi piacerebbe me ne parlassi.
L’Iguana si apre con l’idea di un mare che è concepito come spazio di dominio e di colonizzazione da parte dei Lombardi, scelti come rappresentanti del mondo progredito e industrializzato. In mezzo a questo mare, in un’isola non segnata dalle carte, si incontrano il conte milanese e l’iguanoide proteiforme nei pressi di un pozzo, che propone un’altra acqua. Vi precipitano entrambi, uno dopo l’altro, e ne riescono rigenerati. È un linguaggio simbolico. Lo spiega bene il racconto Pioggia a Milano, dove Anna Maria, disorientata da una pioggia fittissima, perde l’orientamento e smarrisce la via di ritorno a casa. Si siede sull’orlo di una vasca e vorrebbe chiedere informazioni ad una sagoma, una presenza, vicino a lei. E’ una statua, quella di un San Francesco impietrito in una città industriale. Eppure le parla e la invita ad ascoltare l’acqua. Ciò che ci sembra muto e che non guardiamo, ha invece così tanto da dire e se lo chiamiamo, ci risponde. Accogliendo l’invito, Anna Maria per la prima volta vede intorno a sé la città o meglio si lascia guardare. La via che Ortese ci indica, anticipa le riflessioni dell’idrofemminismo. L’acqua ha la qualità di far interagire e partecipare, mettere in connessione, superare i confini individuali e creare ambienti di comunione. Il Sé individuale è agito, si libera nella relazione con un elemento universale capace di permeare e r-accogliere tutto dentro di sé. I temi dell’acqua, del pozzo, del mare ricorrono frequentemente e sono posti in rilievo in Ortese, così come quello dell’ibridazione e della partecipazione. La sua stessa scrittura ha il movimento dell’onda, un ritmo a righe alterne con piloni di ponte. Lo ricorda anche nel suo ritornare su sé stessa per correggersi o nel suo riferirsi ad un «mormorante mare delle immagini interiori». È l’eterotopia dell’acqua, in cui vive l’etica della persona e della scrittura, perché il pensiero stesso è un movimento fluido che, come quello del mare, non tollera costrizioni e ritorna anche su di sé tutte le volte che è necessario.
L’idrofemminismo studia le forme che abitano l’acqua e quelle assunte dall’acqua stessa, perché corpi, cose e spazi al suo interno producono immaginazione, memoria, pensiero. Ne deriva un invito alla cura della pluralità di relazioni, che si instaurano in questo spazio comune con ogni elemento accolto. Ci si muove ovviamente fuori dalla logica della produzione industriale, della gestione dei processi e dell’automazione dei sistemi. È una sollecitazione a considerare la cura che dobbiamo avere di ciò che siamo e di ciò che facciamo, all’interno di un insieme cui apparteniamo.
Contact è un’installazione collettiva giapponese del gruppo Mè, “Occhio”, che rappresenta un oceano di plexiglas. La luce variabile durante la giornata ne modifica la percezione, così come la distanza agisce sulla nostra mente, mostrandoci forme diverse: avvicinandosi, la massa diventa prima onde e poi solo acqua. Non si riesce a possedere l’oceano come un oggetto, neppure chiudendolo in un cubo di plexiglas: la sua mutevolezza è inafferrabile e si sovrappongono piani di realtà nei movimenti di luce e di distanza. Non possiamo neppure comprenderlo o definirlo, perché può essere l’opposto di ciò che crediamo. Elevata di Maria Magdalena Campos-Pons capovolge l’oceano: l’artista è una figura immersa a testa in giù, mentre i capelli si intrecciano con le stelle di un cielo sovrastante. E’ l’abisso che accoglie i migranti, le storie e le speranze, in fondo lo stesso che Ortese racconta nelle sue narrazioni, perché il Mediterraneo è ancora pieno delle vittime della storia. Liquid Path di Filomena Rusciano vede il mare come compenetrazione di corpi migranti, dove umano e non umano, diventano una dimensione nuova dei viventi, intraspecie e senza frontiere. In Acoustic Ocean Sofia Iannok, autoctona di stirpe Sami nel Nord della Scandinavia, è un’acquanauta: registra i suoni del fondo oceanico. Nel video il suo canto, le voci dell’abisso, gli animali, la spiaggia, il digitale, gli apparecchi tecnologici, lei stessa, tutto diventa un insieme che interagisce, si fa corpo unico, post-umano, liquido, multiforme, che in parte si conosce, ma anche mantiene qualcosa del mistero inesprimibile delle singole parti e della loro armonia.
Oggi l’acqua continua ad essere concepita come spazio di dominio, risorsa che scatena guerre, luogo in cui muoiono gli sconfitti. Ripensarla con l’idrofemminismo come spazio di condivisione e convivenza, sarebbe segno di tempi nuovi. Ripensarci tutti come corpi d’acqua, appartenenti ad un insieme vitale da cui non ci si può isolare, sarebbe segno di civiltà e umanità. Significherebbe capire che il male di uno è il male di tutti. Anche Napoli, ne La lente scura, è una donna, sdraiata su una spiaggia, immersa nelle onde della riva, con le mani dietro la nuca e gli occhi che fissano il cielo. Così ci vorrebbe Ortese, corpi d’acqua che rivolgono lo sguardo verso l’alto.
Acoustic Ocean è per me il corpo celeste di Ortese, la patria perduta, cui dobbiamo tornare. Mi chiedo quanto siamo capaci oggi di immergerci, dimenticando confini e frontiere, in uno spazio comune che accolga differenze di qualsiasi genere e specie, nel rispetto e nell’accoglienza dell’altro. Considerandoci anche in una relazione di cura, siamo chiamati a rispondere alla domanda E tu, chi sei?

Quanta importanza hanno vulnerabilità e cura nella scrittura di Ortese?
Inizierei dalle stroncature critiche apparse dopo la pubblicazione di Angelici dolori, che pure ebbe un grande successo. Per Giancarlo Vigorelli Ortese era «una inanità autobiografica» e per Enrico Falqui «uno di quei casi clinici, degni più dello studio della psichiatria che della commiserazione del critico letterario». Le derisioni non le erano mancate neppure in famiglia dopo le prime pubblicazioni di racconti, al punto che aveva chiesto di poter ricorrere allo pseudonimo di Franca Nicosi. Tutta la sua vita ci appare esposta a difficoltà analoghe. Basti ricordare l’ostracismo da Napoli e la frattura con i compagni di “Sud” dopo la pubblicazione de Il mare non bagna Napoli, oppure l’uscita dal PCI per le sue opinioni non allineate. Non ebbe una stabilità abitativa o di rapporto. Le sue amicizie spesso si interruppero bruscamente. Pur ricevendo premi, non riuscì ad avere una serenità economica e riconoscimenti adeguati, che purtroppo sono ancora a venire. Amareggiata, è arrivata a definirsi come un’artista venuta dal nulla che ritorna nel nulla, dopo una traiettoria sbagliata, fuori dalle mura della città. Una marginalità mai dissolta, neppure dopo essere stata la terza donna a vincere il Premio Strega.
Dunque, Anna Maria Ortese è la vulnerabilità dell’umano. Nulla di nuovo, si potrebbe dire, perché le esistenze non sono sempre lineari e semplice. La differenza consiste nel fatto che ha voluto dar voce alla vulnerabilità di tutti. E’ la scrittrice degli ultimi, dei perduti e degli esclusi. Prima di tutto ci chiede di vederli e di ascoltarli. E ci spiega che si inizia lasciandosi guardare dall’altro cessando di raccontarlo con le nostre parole e con la nostra prospettiva.
La vulnerabilità è, in fondo, permeabilità. Come l’acqua, si lascia attraversare.
Una domanda riguarda la scuola. Sappiamo che Ortese ebbe un rapporto difficile col frequentare la scuola tanto che preferì presto abbandonarla. Tuttavia ci sono alcune riflessioni che lei offre sull’ambiente scolastico e sulla educazione. Quali suggerimenti possiamo trarre?
Si trattava indubbiamente di un’altra epoca storica, con una scuola autoritaria ed omologante. Nel suo diario ricorda i giudizi delle sue insegnanti, che la definirono «mostro» e «anormale». L’essere differente non era riconosciuto come un tratto di una individualità, verso cui dimostrare rispetto e volontà di comprensione, ideando piani didattici specifici. Tuttavia, la sua intolleranza verso quel tipo di scuola è un monito verso un’educazione che non sa aprirsi alle differenze, un messaggio sempre utile da ascoltare. Ancora, Ortese ricorda che nella scuola di disegno, la maestra non si accorse di uno scambio di disegni tra lei ed una compagna. Di fondo, si intuisce una scuola priva di relazione e di empatia, che impone modelli da copiare, piuttosto che vie da esplorare.
Anche la costrizione seduti e immobili, che rende insofferente Anna Maria, è una disciplina contraria ai bisogni del corpo, alla necessità di muoversi e sentirsi presenti, che è ambito di discussione oggi. In Angelo bianco, Adelia Battista rievoca momenti di uno studio diverso, che si alimentava di curiosità e di interessi, sostenuto con intelligenza daun bibliotecario. Si può apprendere in modi diversi e più coinvolgenti.
Affiancherei queste considerazioni di Ortese con quelle di bell hooks nell’invito a «insegnare comunità», perché solo questa può essere la «pedagogia della speranza». A scuola si inizia a provare un modo di stare insieme, che influisce sul modo di stare al mondo. Il 28 e il 29 settembre a Roma ci sono stati due giorni di formazione auto-finanziata di Educare alle differenze.
A parte i ricordi delle sue esperienze scolastiche, ho colto soprattutto in Ortese l’invito aliberarsi da quello che lei definisce «un errore nell’educazione culturale», una cecità, un’incapacità di vedere. Credo che soprattutto questa sia l’indicazione più importante, da cui trarre dei suggerimenti. Al centro pone una questione urgente: la necessità di riflettere sui discorsi culturali e delle egemonie/gerarchie che veicolano. Non casualmente usa il termine «cecità», perché, in particolare, bisogna analizzare criticamente il nostro rapporto con la visione, intesa come immagine e come immaginazione, entrambe essenziali nei processi della mente. Un messaggio decisamente attuale.
Memoria e immaginazione sono strettamente connessi nella poetica di Ortese, che per alcuni aspetti potremmo definire profetica o comunque con una sensibilità talmente profonda da intuire quelli che sarebbero state urgenze del mondo a venire. Qual è la tua opinione al riguardo?
La visione della scrittrice è un occhio che osserva quello che gli altri non vedono. Lo sguardo usuale sulla realtà si riduce alla costruzione di un discorso su di essa, che la rende un oggetto banalizzato e gerarchizzato. Lo straniamento, l’occhio obliquo, la prospettiva rovesciata, l’ingrandimento del dettaglio difforme sono strategie con cui Ortese distoglie dalla fissità e dalla parzialità di un’inquadratura unica e immutata. In un certo modo, fa rinunciare alla vista, la confonde, la distrae, e apre alla visione. Si rivolgeall’invisibile e all’assente, sempre. Nel racconto La via del Mare due amici camminano a Napoli. La luce del sole, il mare, le cupole dorate, l’aroma del caffè, le canzoni: ci si addentra in un labirinto di immagini con i sensi accesi da profumi e suoni. Soltanto che a poco a poco non è più la via reale, ma una via della mente, fatta di memoria e di immaginazione. Ci si trasforma senza accorgersene, fermandosi a tratti davanti a cancelli e porte, fino ad una piazza dove la via interrotta riprende e si interna tra le case e «cammina, cammina». Non è più lo sguardo della persona che vede, ma sono le immagini che acquistano vita e narrazione autonoma, vengono incontro, dicono qualcosa della realtà. Su un muretto appaiono centinaia di libri accatastati con le copertine dei personaggi della letteratura. Ora tutto ciò che appare sembra una figura statuaria e i due amici stanno in silenzio. Alla fine sorridono davanti alla bellissima visione. Ritorna successivamente nella via, cercando di risentire «rallegrarsi arcanamente il suo spirito» e alla fine, sfiorando mura di case, dimenticando il suo nome e sentendosi come il fango dei rigagnoli, finalmente ritrova la gioia della visione anche da sola.
C’è in questo racconto un intreccio di vedere, sentire, ricordare e immaginare, che è un’importante scuola dello sguardo. Si guarda la realtà con il corpo e con i sensi accesi, camminando tra esperienza presente, memoria, immaginazione. Questo ci rende umanamente presenti, con la ricchezza di un pensiero composito, unico per un insieme fitto di emozioni, azioni, ricordi, visioni.
Dal secolo scorso siamo esposti ad una proliferazione crescente di immagini, e ora sempre di più anche alla loro falsificazione e soprattutto alla loro privazione di senso. Possiamo ancora scegliere se aggirarci come avatar duplicabili, sovrapponibili e alterabili in un flusso virtuale senza memoria e senza emozione, senza senso e senza verità, oppure apprendere da questa scrittura dello sguardo come vedere con i propri occhi la realtà. La scrittura dello sguardo di Ortese è una disposizione della mente e del corpo, impegnati in uno spazio occupato e attraversato con i vissuti e le passioni che contraddistinguono ognuno.
Guardare è stare in mezzo al mondo, accoglierne le immagini e scegliere le proprie, mantenere vitale un immaginario interiore che si unisca a quello di altri e produca visioni, orizzonti di senso, un’umanità in crescita.


No Comments