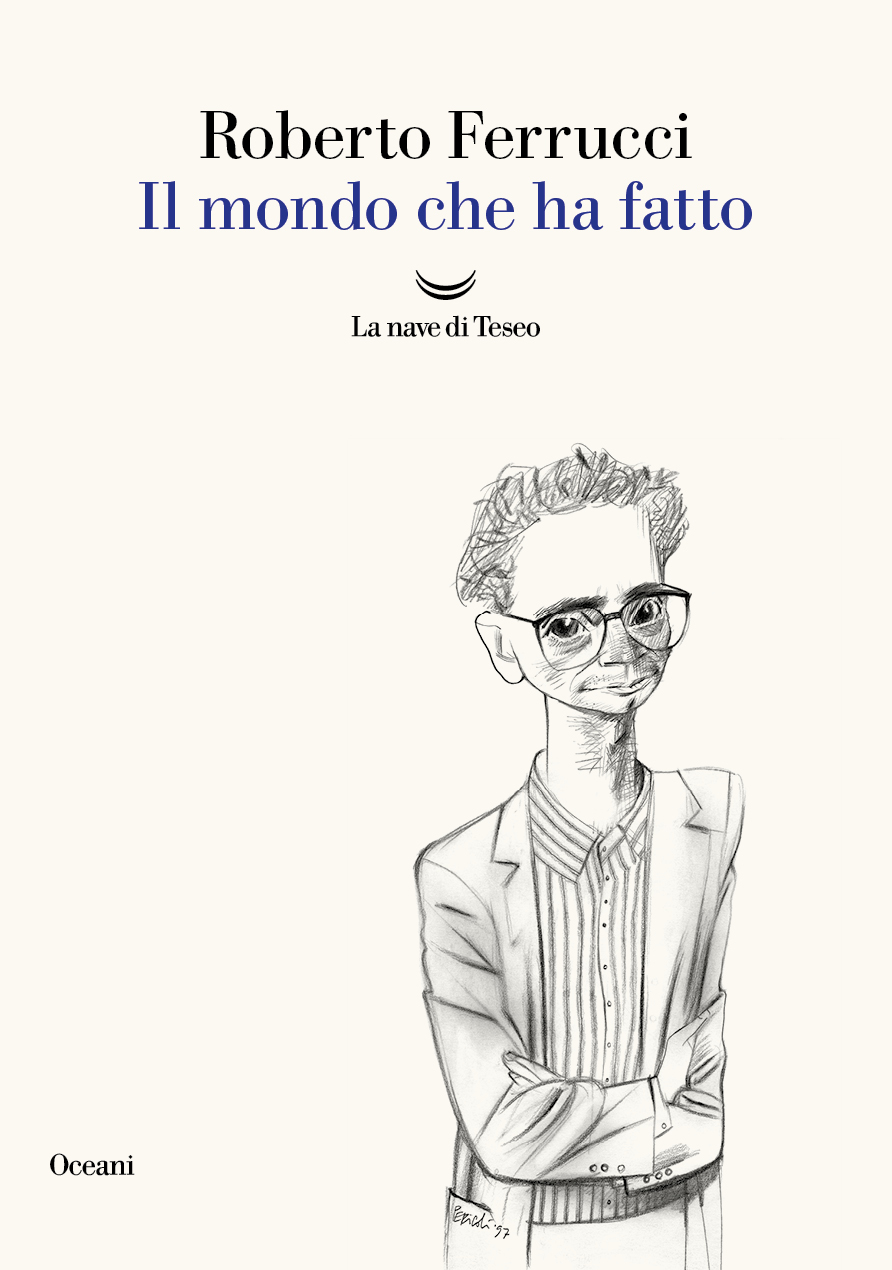
09 Apr Venire al linguaggio – Per Daniele Del Giudice scrittore della precisione
di Ugo Morelli
Memoria, emozioni e sentimenti si possono intrecciare fino alla vertigine, o all’ingorgo, che può assumere le sembianze di un nodo alla gola, tanto più impegnativo da non riuscire a sciogliersi se non nella fuga o nelle lacrime. Se poi quello che si sente si combina e ancor più si intreccia con quello che sente un’altra persona, con affinità e risonanze sorprendenti e inaudite, si produce una sospensione o quasi una paralisi espressiva. Eppure, nonostante tutto, prevale la voglia di scrivere, come accade a me, coinvolto in questo testo di Roberto Ferrucci, Il mondo che ha fatto, La nave di Teseo, Milano 2025, fino alla soglia del silenzio.
Non credevo ai miei occhi, quando su uno scaffale di una libreria romana ho visto una copertina con il disegno che Tullio Pericoli mi aveva mostrato nel suo studio di Milano, e che parla di Daniele Del Giudice meglio e più di tante fotografie. Non posso nascondere che ho preso in mano il libro e l’ho sfogliato con una certa precauzione. Quella precauzione che si fa preoccupazione ogni volta che sento parlare di Daniele o che sono di fronte ad uno scritto che lo riguarda. Perché? In me si è creata negli anni, sia della nostra frequentazione ed amicizia, ma soprattutto dopo, una convinzione difficile: che a Daniele Del Giudice e alla sua opera si addicano due cose: la lettura e rilettura dei suoi libri e il silenzio della parola. Quel “venire al linguaggio” di cui spesso parlava e che per lui era vicino al sacro, è il criterio che secondo me più gli si addice. Una mia ossessione, naturalmente, ma è allo stesso tempo il codice del mio rapporto con la sua opera e, forse, un modo per tentare vanamente di elaborare l’inaccettabile sua mancanza. Quando ho aperto il libro di Ferrucci e subito dopo ho cercato una sedia per continuare a sfogliarne le pagine, a leggere voracemente, a cercare di muovermi tra la tentazione di chiuderlo se una nota stonata mi avesse offeso e l’attrazione incontenibile e progressiva di non perdere una parola, mi sono ritrovato in un’atmosfera irrinunciabile, che subito è andata oltre le righe e le parole, che convocava Daniele in presenza, quasi che lui e l’autore fossero seduti vicino a me in quella libreria. Più leggevo, più vedevo Daniele schivo, ironico e riservato di fronte a un libro che parlava di lui e Roberto Ferrucci consapevole di aver sfidato il quasi impossibile, facendo un dono più unico che raro per comprendere uno dei più grandi scrittori dell’ultimo secolo. C’è voluta un’occhiata interrogativa della gentile libraia per farmi andare in fretta verso la cassa, pagare e correre in un luogo dove poter continuare a leggere fino alla fine delle 380 pagine, per poi tornare sui capitoli, sui paragrafi, sulle fotografie, sulle parole di questo libro imperdibile.

Una lettura corporea, sinestetica, topologica, perché Ferrucci, con un linguaggio limpido e denso di sentimenti sempre ben misurati, propone un mondo nel mondo: il mondo della sua relazione di amicizia profonda con Daniele Del Giudice, e il mondo che Del Giudice ha creato, o meglio ha fatto, come egli stesso ha detto a Ferrucci consegnandogli alcune sue opere: “è il mondo che ho fatto, quello” [p. 20]; da cui il titolo del libro. Le coincidenze sulla descrizione delle quali devo essere cauto e parco, per la risonanza quasi incontenibile tra il lavoro di Ferrucci, il mio mondo interno e la relazione con Daniele Del Giudice, portano proprio nei paraggi di una convinzione: che la poetica di questo autore sia stata capace di creare, e non solo di descrivere, il mondo che ha narrato. Proprio questo dicevamo in una sera di qualche mese fa a Bolzano, parlando di Del Giudice con Massimo Cacciari, un altro amico comune che con lui ha condiviso molto. Situato sulla soglia del tempo della sua esistenza, Del Giudice ha scritto per il proprio presente ma, verrebbe da dire, con il tempo del futuro anteriore. E Ferrucci coglie l’essenziale di quella poetica in un intreccio, appunto, tra vita e narrazione, tra gioia e sofferenza, tra gioco e dolore. Non conosco Roberto Ferrucci, né gli ho mai parlato, ma ora è venuto a far parte di un piccolo collegio invisibile, un micro sistema di satelliti che ruotano intorno alle opere e al lascito di Daniele. Non mi riferisco a tutti i lettori che nel mondo leggono le sue opere, ovviamente, ma ai pochi che hanno potuto godere della sua compagnia, come alcuni con i quali ci trovammo pochi anni fa al Museo Caproni di Trento per parlare di lui e della sua opera in un luogo che conteneva macchine volanti, – una in particolare, il trimotore Aermacchi -, che più volte era stato a visitare. In quella sera tra gli aerei del Museo furono disposte le fotografie di Giuseppe Varchetta, che a lungo ha fotografato Daniele e che me lo aveva fatto conoscere un giorno a Milano. Le coincidenze possono essere effettivamente vertiginose e da subito, leggendo il libro di Ferrucci, se ne presenta una che parla da sola: il primo incontro con Daniele in occasione della presentazione di un libro.
Per Roberto Ferrucci Atlante occidentale a Mestre, per me Lo stadio di Wimbledon a Milano. La mia copia con la dedica che richiama la nostra prima conversazione e la compagnia che quel libro mi ha fatto e mi fa, la ritrovo nel racconto di Ferrucci. Se Daniele toglieva dalla sua scrittura “tutto quello che è sentimentale” [p. 208], la sua compagnia è sempre stata di un’eleganza affettiva inenarrabile, sia che si fosse a fare scherzi in un baccaro veneziano, sia che si assistesse al suo ragionare rigoroso e impeccabile. Ed era sempre solo l’inizio. Rimaneva ogni volta un senso incompiuto e il desiderio di continuare. Ma allora questo libro che cos’è? È molte cose e dà molto, proprio molto, a chiunque lo legga, in termini di analisi della letteratura contemporanea, di storia di un’amicizia, di immersione nella complessità e imprevedibilità della vita, di una “vita che si vendica sulla scrittura”, come scrive Tiziano Scarpa nell’aletta della copertina del libro.

Ferrucci inizia dai gesti e li riporta alla tecnica: a quella tecnica come corpo, combinata col corpo, in modo inconfondibile, come chiunque abbia visto anche solo una volta Daniele Del Giudice girare e rigirare una matita tra le sue lunghe dita ossute, o prendere e sfogliare il proprio libretto di volo di cuoio marocchino. Voleva essere un tram o un aereo, da piccolo, Del Giudice e non ha mai smesso di fare della tecnica una delle fonti della propria poetica, come Ferrucci mostra in tutto il libro, riportandomi a un pomeriggio alle Terme di Comano, in Trentino, in occasione della presentazione di Staccando l’ombra da terra, quando attraversando un parco che aveva appena definito degno dei migliori parchi inglesi per come era ben tenuto e accogliente, si è poi perso a contemplare ed analizzare una vecchia e arrugginita turbina elettrica in disuso trasformata in monumento. Il libro di Ferrucci è attraversato da un’estetica del dolore, oltre che di tante altre emozioni che una relazione di amicizia così intensa è in grado di generare. Fin dalle prima pagine si è condotti nel dramma della crisi della memoria e della demenza che hanno afflitto così precocemente Daniele Del Giudice, fino a causare le derive angoscianti di “una lingua fisicamente staccata da lui, lontana dal suo corpo” [p. 16]. Seguendo la deriva della malattia di Daniele siamo stati travolti da una domanda: come può la lingua staccarsi da uno dei suoi più rigorosi cultori? Chi di noi ha vissuto l’inizio di quel dramma ha dovuto vivere il trauma con incredulità. Arrivando a Trento, al Master in Arte e Cultura, dove lo invitavo per una sua lezione annuale, l’ultima volta che è venuto è stata per me la prima dell’inizio del dramma. Arrivando mi ha dato una copia del testo della relazione che avrebbe svolto e mi ha chiesto, essendo seduti vicini, di seguire il testo e aiutarlo se si fosse interrotto. Ho sorriso dicendogli: chi? Tu? Ha sorriso anche lui con me, ma non quando alcune volte mi ha guardato come alla ricerca dell’aria, mentre cercava la parola per proseguire. Come accade a Roberto Ferrucci nella straordinaria tessitura della sua narrazione di eventi analoghi, avrei voluto fuggire o abbracciarlo, impiegando poi molto tempo a smettere di oppormi all’evidenza. Ma, come Ferrucci, non penso di esserci mai riuscito. La conoscenza con Del Giudice, intorno alla passione per la letteratura, si intensifica anche grazie alla ricerca che Ferrucci sta conducendo per la propria tesi di laurea: La nuova narrativa italiana, Daniele Del Giudice e Antonio Tabucchi. Quell’intensificazione porta dritta all’esattezza, alla ricerca maniacale e ragionata della precisione: Del Giudice come scrittore della precisione. Nell’epoca in cui la cosa è la nostra immagine della cosa, in cui la cosa si è desostanzializzata, l’esattezza sta nel descrivere al quadrato le cose, non in una prospettiva corrispondenziale e rappresentazionale. L’esattezza non è qualcosa di deterministico e meccanico, ma è un gioco di approssimazione, come l’ombra che rimane comunque a terra quando te ne distacchi, dove si deve comunque tornare. Come accade col sacco condominiale dell’immondizia, una specie di scrigno delle meraviglie, che Roberto Ferrucci ha ricevuto un giorno da Daniele Del Giudice e che, seppur rimasto sepolto sotto pile di giornali nella casa dei genitori, quando viene ritrovato continua e emanare risultati straordinari sui quali, tra l’altro, Ferrucci costruisce una parte importante della sua narrazione. Tornare alla fonte, tornare alle origini, tornare alla terra. Ma anche percorrere e ripercorrere Venezia, senza mai scrivere di Venezia, ma abitandola facendosene ispirare in modo intimo e pervasivo, diventando il luogo dove solo è possibile scrivere per Del Giudice. Venezia base sicura, luogo di adozione, piattaforma accogliente e luogo di incontri e di affinità elettive, da Massimo Cacciari a non molti altri. La discrezione e la presenza schiva sono stati tratti costanti nella vita di Daniele Del Giudice, persino nel timbro della sua voce, che giungeva dal profondo, scandita e limpida – ho sempre pensato allo scorrere dell’acqua in un torrente di montagna, ascoltandolo – misurata come le parole la cui appropriatezza non smetteva di stupire all’ascolto. Venezia amata anche dall’alto e grazie alla passione per il volo e alla realizzazione del sogno di volare dovuta, appunto, ad un’amicizia, quella con l’istruttore.
Una straordinaria narrazione di un’amicizia è anche il libro di Roberto Ferrucci. Tra tutti i caratteri del testo, quello di proporre una ricchissima e complessa relazione di amicizia è forse il contributo più coinvolgente e documentato del libro. Risuona nel libro quanto Daniele Del Giudice dice a Ferrucci nell’intervista che gli fa in occasione della pubblicazione di Atlante Occidentale: “…è anche un romanzo sull’amicizia. Certamente, attraverso l’amicizia dei due protagonisti, il giovane fisico Pietro Brahe e lo scrittore Ira Epstein, io inseguo anche la possibilità di un’amicizia con quest’epoca. Il che non vuol dire rinunciare a criticarla, a giudicarla, a modificarla; vuol dire però cominciare a conoscerla nella sua essenza, e questa essenza per me è il cambiamento delle cose che ci circondano, è l’accelerazione della tecnica e della scienza che irrompono sempre più nella nostra esperienza quotidiana. Mi sembra che questa esperienza chieda un nuovo modo di essere e di sentire. Al sentire io dò grande importanza, così come a tutti gli aspetti che lo compongono, sia quello affettivo, sia quello percettivo, sia quello della conoscenza. Direi allora che Atlante occidentale è una storia di sentimenti e di passioni forti. Solo che di questi sentimenti, ripeto, io cerco di raccontare la parte che cambia in rapporto alle cose che ci sono oggi, e che sempre più ci saranno. E raccontando questo cambiamento, cerco anche un cambiamento, pur piccolo, dentro di me”. Del Giudice continua: “Così l’effetto di ciò che scrivo non resta soltanto sulla pagina, ma continua anche nel prolungamento fra il libro e chi lo legge. Ho avuto fin da ragazzo la passione di come funzionano le cose; smontavo i motorini dei miei amici, e non lo facevo soltanto per una grande curiosità, ma perché ancora oggi mi sembra che la nostra vita sia fatta tutta del rapporto con le cose, e le cose hanno poi un potere evocativo, non sono soltanto dei puri oggetti. Descrivere gli oggetti significa per me descrivere i gesti e i movimenti e i modi di essere cui gli oggetti ci obbligano. E per descriverli devi conoscerli” [pp. 99-100]. Come è evidente in questo testo, è difficile trovare un’altra dichiarazione capace di consentire l’ingresso nel mondo di Daniele Del Giudice, meglio delle parole appena riportate. Sono molti i testi in corsivo che Ferrucci riporta nel libro, parti di dialoghi e interviste, conversazioni e appunti derivanti dalla sua intensa relazione con lo scrittore. Si tratta di uno dei contributi più importanti, nati all’interno di un’intensa amicizia, per comprendere la poetica e la scrittura di Del Giudice.
Atlante occidentale, probabilmente il capolavoro dello scrittore, affronta il problema centrale della nostra civiltà, il rapporto tra la scienza e la possibilità di farsi un’immagine della realtà che è diventata invisibile, perché da tempo si è dissolta la cosa. Cercare la parola per dire un presente che si dissolve a guardarlo, rintracciare ciò che la parola illumina, e venire al linguaggio diventano proprio in questo libro uno dei vertici della sua poetica. Un libro anticipatore, capace di parlare al futuro anteriore. Quel Futuro necessario, che fu il tema della prima edizione di Fondamenta, concepita e realizzata per alcuni anni a Venezia, dando un contributo di elevato pensiero alla ricerca in quegli anni di inizio millennio. Come documenta Ferrucci ancora una volta in un’intervista realizzata in occasione dell’ultima edizione di Fondamenta, Del Giudice riteneva la nostra un’epoca di bassa progettualità, anzi di mancanza di progettualità. Un’epoca alla ricerca di Significati condivisi, come recitava l’edizione del 2002. “I significati condivisi sono quelli che ciascuno cerca per trovare un minimo di orientamento e mettere insieme il proprio percorso di persona con gli altri”. “…la vera differenza è tra le persone, le figure dell’individualismo compiuto, assoluto, e le figure delle persone che pensano, che sono e vivono nella relazione con gli altri, che dagli altri si sentono determinate e che dell’essere con gli altri hanno un vero e proprio bisogno” [p. 206].
Fa impressione, oggi, nel tremendo tempo dell’individualismo neoliberista effettivamente compiuto, leggere parole così profetiche. “Con chi parli? Oggi”, mi aveva detto Daniele a Trento, in margine ad una lezione. Una delle più portentose produzioni di ordine di discorso è quella di “individuo”, vale a dire di un soggetto portatore di una identità, di una storia unica e irripetibile, di istanze e bisogni e desideri che gli sono propri, che decide “individualmente” di entrare in relazione con altri individui e che in tale relazione trova gli alimenti della sua identità e gli elementi che gli renderanno possibile costruire la sua storia. Una costruzione concettuale apparentemente ineccepibile. In base a quell’ordine di discorso l’individuo fornisce un modello della realtà.
L’evoluzione di questi fondamenti si è trasfusa nella concezione neo-liberista del soggetto – vale a dire del soggetto individuo – come imprenditore di sé, caratterizzato:
– dalla fattività, ovvero la capacità di trasformare il proprio ambiente sociale e naturale per piegarlo ai propri bisogni, contro la riflessione e speculazione della realtà, al registro estetico nel rapporto col mondo;
– dall’affermazione del primato della razionalità, per cui ogni cosa è possibile solo quando la scelta cade sul registro razionale;
– dalla trasformazione strumentale della durata temporale in blocco sincronico, congelamento dell’istante, neutralizzazione dell’attesa mediante la manipolazione del sé corporeo.
– da una disciplina formidabile del soggetto/individuo votato all’affermazione del proprio primato, dotato di tutto un arsenale di strumenti che gli consentono di imporsi come il centro gravitazionale del proprio mondo, illuminato da una fonte inesauribile e incorruttibile di sapienza razionale, agente razionale in un mondo razionale.

Il neo-liberismo individualista con la sua macchina mitopoietica ha portato il tema dell’individuo al suo zenit ideologico, producendo un ordine di discorso che si propone come verità unica. La solitudine prodotta e confermata da un circuito che si avvita su sé stesso, divenendo impostura. Come ha intuito felicemente Jean-Philippe Toussaint, Daniele Del Giudice ha cercato “attraverso la letteratura, di arrivare al pensiero, alla riflessione, alle idee. Il suo è un rapporto nuovo con la scrittura” [p. 228]. Lo riporta Ferrucci, parlando dell’incontro suo e di Daniele, con quello scrittore. In quest’epoca amara, molto di quanto Del Giudice ha scritto, detto e pensato potrebbe essere ricondotto a un titolo di una conversazione tra lui e Italo Calvino: C’è ancora possibilità di raccontare una storia? Scrive Del Giudice, citato da Ferrucci: “Il venir meno dell’esperienza, la comunità di inesperienze ridotte a puri eventi, rendono più problematica e complessa la soggettività di un narrare. (…) Voglio dire: dove può trovare origine un narrare, nell’indifferenza degli eventi?” [p. 235]. Eppure nel dialogo con Calvino emerge una delle fonti principali della poetica di Daniele Del Giudice: “Che tipo di ‘narrazione’, è questa? Ho l’impressione che tutti i nostri tentativi di dire il ‘reale’, sebbene ormai irreversibilmente scissi in linguaggi particolari, abbiano però proprio nei punti di conflitto e di differenza tra questi linguaggi, un qualche collegamento. È possibile che E=mc2 sia uno dei più bei racconti mai scritti” [p. 242]. Ferrucci, documentando il sodalizio e il dialogo con Calvino, riprende una riflessione di quest’ultimo che riporta efficacemente al valore e al senso della scrittura e della narrazione sia per Calvino che per Del Giudice: “Il fatto che la vita è una, che ogni avvenimento è uno, comporta la perdita di miliardi di altri avvenimenti, perduti per sempre. Narratore è colui che vuole sottrarsi a questo destino” [p. 243]. E Del Giudice a quel destino si è sottratto; lo ha fatto con una complessa combinazione tra poetica e tecnica, con una nettezza dei sentimenti e una sensibilità rara. Quella stessa sensibilità che emerge quando, come condivide nel libro Roberto Ferrucci, parla di musica. “La musica è molto più che un’emozione, aggancia ritmi interni, il suo effetto è un’azione che porta in superficie zone d’ombra di noi stessi. Cerchiamo sempre di descriverle in termini verbali, ma non è facile. Però, a me piace provare a raccontarla, dentro a una narrazione, la passione che ho per la musica” [p. 288]. Anche da questa peculiare attenzione alla musica emerge il tratto distintivo di Daniele Del Giudice, maestro delle parole: la precisione. Una precisione che si fa narrazione, racconto. Nel libro In questa luce, Daniele scrive: “Nominare, descrivere-quando diciamo bottiglia o cravatta o nuvola-è come fare un piccolo cono di luce, che porta immediatamente con sé una parte d’ombra, l’ombra di ogni parola” [p. 290]. Come chiaramente documenta Ferrucci, Daniele Del Giudice non è che la cercasse l’esattezza, era naturalmente semplicemente parte del suo stare al mondo e della sua poetica: “Non è che io cerchi l’esattezza, semplicemente non si capisce perché si debba essere generici se si possono dire le cose con precisione, chiamare le cose con i loro nomi” [p. 310]. Un esercizio di esattezza lo facemmo insieme con molto divertimento, prima che si accingesse a leggere il racconto Fuga, dal suo libro Mania, al Festivaletteratura di Mantova. Voleva che lo aiutassi, io napoletano di origine, a perfezionare la sua pronuncia delle parole e dei versi della canzone napoletana che fanno di quel racconto una delle sue narrazioni più coinvolgenti. Con il contenuto di una comunicazione di Del Giudice in una delle tante conversazioni personali che Ferrucci dona a chi legge il libro, – e non senza una commozione sentita in quella comunità di persone che hanno avuto il privilegio di condividere tempo e pensieri con Daniele Del Giudice -, penso sia tempo di concludere questa riflessione suscitata da una narrazione di particolare intensità, quella di Ferrucci, che documenta un’amicizia e una condivisione emblematiche [p. 311]: “Io sono tra quelli che tendono a ricavare la soggettività dall’oggettività, a far emergere una figura dalla sua collocazione nello spazio, dai suoi movimenti, da una complessità di particolari relazioni con gli altri e con le cose, gli oggetti che, se rappresentati con esattezza, con precisione, dovrebbero produrre insieme l’immagine di un personaggio e il suo ‘sentire’ ”.


No Comments