
23 Nov Intervista a Beatrice Masini
a cura di Giulia Gadaleta
Beatrice Masini è una scrittrice e traduttrice italiana. Tra i suoi lavori, la resa in italiano di alcuni dei libri della serie di Harry Potter di J.K. Rowling, per la versione pubblicata da Salani. Il suo romanzo Bambini nel bosco (Fanucci) è stato finalista al Premio Strega nel 2010. Si tratta della prima opera per ragazzi ad aver mai concorso nella storia del premio. Con il romanzo per adulti Tentativi di botanica degli affetti (Bompiani, 2013) ha vinto il premio Selezione Campiello, il premio Viadana, il premio Alessandro Manzoni. Del 2016 è I nomi che diamo alle cose, sempre per Bompiani. Nel 2018 ha pubblicato la raccolta di racconti Più grande la paura (Marsilio). Nel 2022 per la casa editrice Giulio Perrone, nella collana Mosche d’oro, ha scritto su Louisa May Alcott, restituendone un ritratto assai interessante: “Che bello sarebbe poter finalmente scrivere quello che vuole e basta, senza dover rimestare le zuppette moralistiche richieste a gran voce dagli editori e dal pubblico. Forse potrebbe anche azzardarsi a farlo, se fosse sola al mondo, se dovesse provvedere solo a sé stessa: ma ancora e ancora la famiglia è più forte. Ci sarà sempre una sorella vedova da sostenere, una sorella promettente a cui pagare gli studi, una sorella morta da sostituire”.
I suoi libri sono tradotti in una ventina di Paesi.
Giulia Gadaleta l’ha intervistata per “Morel voci dall’isola” cercando di scoprire meglio il suo legame con la lettura e con la scrittura e restituendoci un punto di vista originale e prezioso.
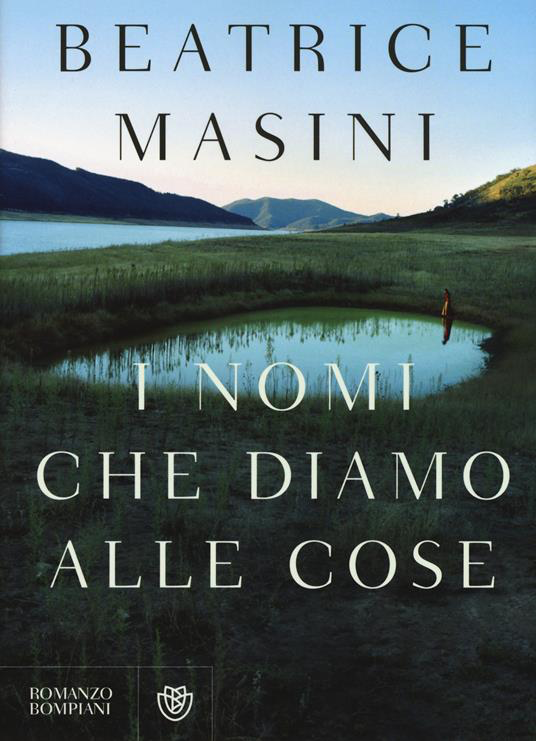
Negli ultimi anni ti sei dedicata ad alcuni romanzi per adulti. In Tentativi di botanica degli affetti e I nomi che diamo alle cose mi sembra che tu segua una tua ossessione per le case, come se fossero dotate di un’anima loro propria. La villa del Manzoni e la casa che Anna eredita da Iride Bandini hanno qualcosa in comune?
“Ognuno di noi ha due case – una concreta, collocata nel tempo e nello spazio; l’altra infinita, senza indirizzo. E viviamo ad un tempo in entrambe.” È una frase di Olga Tokarczuk. La mia casa infinita ha assunto molte forme, anche nei libri per ragazzi ci sono tante case, che parlano, pensano, scricchiolano, vivono vite proprie. Sono le case possibili, e anche le case dei personaggi, che non sono veri ma possibili. In comune hanno il fatto di cambiare di continuo, sono elastiche, si adattano agli slanci. Sia la casa di don Titta-Manzoni che quella di Anna sono tutte mie. Che impero immobiliare si può costruire col desiderio.
Credo che I nomi che diamo alle cose sia il tuo libro-manifesto: Iride Bandini è una scrittrice per ragazzi che lascia in eredità una casa a colei a cui ha affidato le proprie memorie, Anna. È una donna difficile, caratterialmente e umanamente, e mi pare che il tema di questo romanzo sia la maternità e quanto la maternità abbia a che fare con la scrittura per ragazzi, è così?
Iride è l’antiscrittrice per ragazzi, non coincide con l’idea preconcetta che abbiamo, a lei i bambini non piacciono, piuttosto le interessano. Bianca Pitzorno in Storia delle mie storie scrive che da uno scrittore per ragazzi ci si aspetta sempre una sorta di maternage, che sconfina nell’intrattenimento; ma lo scrittore per ragazzi non è un pagliaccio né un fantasista. Iride è una donna che non fa sconti, senza zucchero, che è madre però mette da parte tutto quanto per il lavoro; al tempo stesso i bambini li ascolta, li osserva senza avere la pretesa di comprenderli. Riesce a capire che storie fare per loro e lo fa senza calcolo: le sue storie non sono prodotti ma qualcosa di naturale, sgorgato dal gusto puro del racconto e alimentato dalla sua conoscenza dei bambini. In contrasto con quegli scrittori che sono convinti di sapere che cosa va detto ai ragazzi. Beati loro.
C’è insomma tanta pappa morale, per dirla alla Alcott, ancora oggi?
Oh, certo. Anche –anti, mascherata dal suo contrario, la trasgressione a tutti i costi, la convinzione che occuparsi di problemi scottanti o anche semplicemente attuali sia una manifestazione di serietà nei confronti del pubblico. Invece è una moda: agganciare l’attualità spesso vuol dire piegarsi a scrivere un certo tipo di storie che funzionano bene nelle scuole, che vengono usate.
Mi vengono in mente i libri sulla mafia per ragazzi…
Alcuni (pochi) nascono da uno slancio autentico, da conoscenza profonda dell’argomento; altri sono totalmente d’occasione. Se scrivi a tema il rischio di scrivere qualcosa di stereotipato e guidato dal messaggio è altissimo.
Anna, la protagonista de I nomi che diamo alle cose, viene definita un’“ascoltatrice”: di lei Umile dice che “presta le parole agli altri”. Quanto scrivere per ragazzi è ascoltare e quanto è inventare?
Scrivere per ragazzi è più inventare che ascoltare, anche se prima devi aver ascoltato per fare tuo un certo vocabolario, e guardato bene, per far tuo un certo sguardo. Ma più importante è la voce. Più importante è avere memoria di quello che si è stati come bambini e tenersi stretto quel piccolo tesoro di sensazioni, impressioni. L’immaginazione si innesta su una base di fortissima realtà. Anna è l’ascoltatrice per professione: ci sono persone che lo fanno molto bene, i ghost writer, gli editor, in grado di aiutare un autore a dare il meglio senza essere invadenti. In I nomi che diamo alle cose ho parlato anche del mestiere che faccio e che vedo fare tutti i giorni, quel romanzo è uno sguardo sui mestieri della scrittura.
In I nomi che diamo alle cose Anna trasloca nella casa ricevuta in eredità da Iride, in un luogo per lei nuovo, e si confronta con chi in quel luogo è nato o l’ha scelto prima di lei. Mi sembra che in qualche modo si chieda cosa significhi mettere radici: la risposta che trova nel corso del romanzo ha a che fare con il compito che ciascuno di noi si dà, fare e rifare quella cosa anche se al mattino sarà disfatta. Una cosa che giudichiamo come ossessiva in chi ci ha preceduto, in chi è più vecchio di noi. Mi sembra che in questo ci sia un aspetto della tua poetica.
Sì, forse va insieme al desiderio di non essere troppo giudicante, mai, ognuno ha i suoi percorsi che sono segnati da circostanze esterne insondabili. Credo la si possa definire una forma di liberalismo, io sono io, so dove sono, cerco di saperlo, tu sei lì, le nostre strade si incrociano, ci sono incroci genetici o casuali, però restiamo entità diverse e ciascuno risponde solo a sé stesso di quello che fa, di come lo fa.
Dire che sei un’autrice prolifica è banale: hai scritto di tutto, albi illustrati, riscritture di miti e fiabe, serie per bambine (cit…), romanzi distopici. Mi sembra che Bambini nel bosco e La fine del cerchio formino un dittico, il primo è un post apocalittico, una distopia, il secondo il dopo, la ricostruzione…
…con dei fili sottili sottili che li legano che di fatto sono poche pagine…

Nel primo c’è il cerchio che si costruisce e nel secondo il cerchio che si apre…
Bambini nel bosco è uno dei libri più complicati che ho scritto, mi ci sono voluti cinque anni, La fine del cerchio meno perché è organizzato in tre racconti concatenati e avevo già preso le misure di questo genere che non avevo mai pensato di affrontare. L’immaginazione spostata nel futuro dà un sacco di possibilità: quando leggo per mestiere i nuovi romanzi per adulti, italiani e no, spesso mi trovo a leggere storie che ho già incontrato decine di volte nei libri per bambini e per ragazzi, anche quelli di cinquant’anni fa. Sembra che gli adulti arrivino sempre in ritardo. Margaret Atwood era arrivata alla distopia da un pezzo, e non se n’era accorto nessuno. Penso ad un grandissimo scrittore per ragazzi americano che si chiama M.T. Anderson, affronta temi e soggetti che ho visto ri-rivisitati tante e tante volte. È chiaro che le idee sono di tutti e sono sempre le stesse, tutto sta in come le sviluppi. Quando mi sono lanciata in questa distopia mi sono resa conto delle possibilità che consente ma anche dei limiti: quando usi tanto l’immaginazione devi sapere anche dove fermarti. Questo vale anche per il fantasy. Perché molti fantasy non funzionano? Perché sono triti e sfuggenti, si capisce che l’autore non sa controllare la materia e continua a riempire la storia di invenzioni incoerenti. In Bambini nel bosco c’è stato un gran lavoro di costruzione e meditazione. Quanto al finale aperto, è in qualche modo un omaggio all’Asimov delle Cronache della galassia: l’ho letto da ragazzina e ho continuato a pensare a questa idea molto semplice dell’infinito che non è né diritto né rovescio, né sopra né sotto.
In Bambini nel bosco c’è un libro di fiabe terrestri che viene letto e cementa questo gruppo di bambini fuggitivi e li trasforma in una comunità, li fa crescere e scoprire l’importanza della memoria e del tempo, mentre ne La fine del cerchio questo ruolo delle storie non c’è, perché? Perché è l’inizio e dunque non c’è il tempo?
Forse sì. In La fine del cerchio ho pensato che ovunque fossero finiti, questi bambini ricominciano davvero daccapo, dall’inizio del mondo. Il libro, la storia scritta può arrivare solo molto più in là. Le storie ci sono, anche lì i ragazzini si raccontano subito delle storie, però non c’è il libro come oggetto, la civiltà è da venire, è stata azzerata, quindi sono più importanti i sensi.
…e l’addestramento a fare le cose…
Sì e anche a fare le cose, porsi i problemi e fare le cose, anche in circostanze diversissime. Il racconto africano è nato dall’unico viaggio che ho fatto in Africa, sono stata in Tanzania per Oxfam ed eravamo in un’isola sul lago Victoria, lì non c’erano tantissimi animali perché non era la stagione giusta, ma la sensazione di essere all’inizio del mondo, con l’acqua, con il verde, con queste lucertole azzurre grandi così, tutto un po’ più grande e tutto così vivo… però anche quelle distese di plastica impigliate nei rami, una visione orrenda.

Invece il terzo racconto, quello nella villa ottocentesca, è sempre ambientato nella villa del Manzoni come Tentativi di botanica degli affetti?
No, nella mia testa è più una villa veneta, uno di quei posti un po’ magici con le stanze dentro le stanze dentro le stanze, con i trompe-l’-oeil sulle pareti… È un po’ la connessione del futuro con il passato, lì la casa esiste, è rimasta, e devi trovare quel che ti serve in un posto che non hai costruito tu e che non è stato costruito per te.
Tra le riscritture di fiabe ho trovato Blu, un’altra storia di Barbablù (Pelledoca edizioni). Quando Blu scopre i resti delle altre mogli di Barbablù nel suo diario-confessione ci dice che non comprende le ragioni per cui lui le abbia uccise. C’è questa frase che si ripete “aveva fatto o non fatto qualcosa, dalla storia non si capiva bene”. Come mai?
È chiaro che Barbablù chiama il tema del femminicidio, però questo non è un libro a tesi, è solo la riscrittura di una fiaba. Perché Barbablù uccide le sue mogli? La fiaba è estremamente elusiva, i perché restano senza risposta, le fiabe ci raccontano cosa e come, perché quasi mai, è la loro logica. Io ho scelto di assumere il punto di vista di Blu, l’ultima delle mogli, l’unica che scamperà alla strage, perché è più facile, perché noi stiamo dalla parte del buono e non del cattivo. Blu non ha capito perché non può insinuarsi dentro la testa di Barbablù. Noi non sappiamo mai cosa scatta nella testa di chi compie certi gesti di violenza suprema, è rabbia, squilibrio, incapacità di controllare i propri gesti, ancestrali differenze o diseguaglianze che riaffiorano…
.
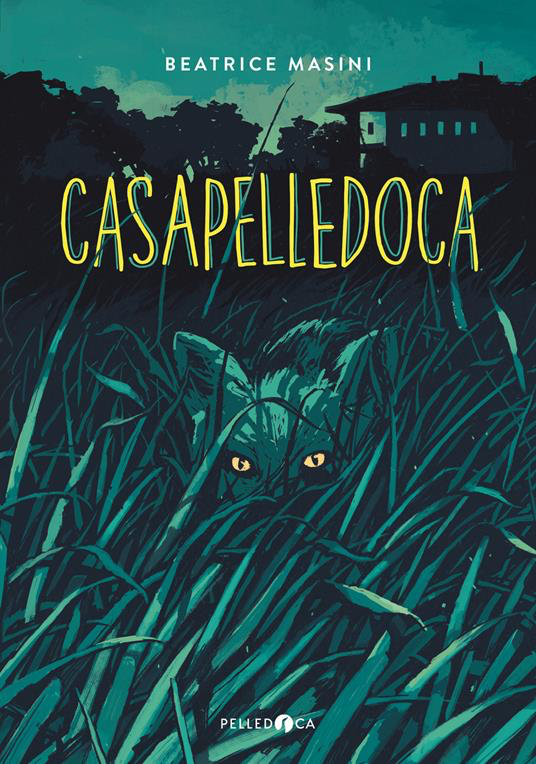
Invece in Se è una bambina hai lavorato sull’alternanza di due voci: la voce della bambina che si deve raccontare che la sua mamma è morta e ci mette tutto il libro e la voce della mamma che la osserva da questa limbo in cui è confinata, che tu chiami l’armadio degli scettici. Da che esigenza è nato?
Avevo scritto due pagine con questo tipo di prosa, senza punteggiatura, dando voce al flusso di pensiero di una bambina piccola. Quella voce si è incrociata con le storie di famiglia di mia mamma: i suoi genitori morirono entrambi in un bombardamento, lei era la più piccola e fu spedita in un orfanotrofio per orfani di guerra a Verona. Quando eravamo piccoli ci raccontava spesso questi pezzi di vita, poi a un certo punto ha smesso. Però questi suoi racconti erano rimasti tutti lì; lei era stata molto bene, le suore erano buone e gentili, ma era sempre un luogo di solitudine, di affetti sostitutivi. Ho iniziato ad interrogarmi su cosa significa crescere senza una mamma, trovarsi da soli, saperlo ammettere, capire e non capire, avere intorno un mondo di adulti che subiscono la tua stessa perdita ma in qualche modo se la cavano, invece tu sei piccola e sei sola: ecco, è venuto da lì.
I cani sono onnipresenti nei tuoi romanzi. Penso al cano, ibrido tra cane e maiale di Bambini nel bosco ma soprattutto a Solo con un cane in cui un bambino fugge con il suo cane per salvarlo dall’editto feroce che vuole tutti i cani morti.
Anche questa è una cosa legata a mia mamma: quando ero piccola e andavamo in campagna dai parenti la vedevo tornare in un attimo così naturale con gli animali, i cani venivano a lei, lei sapeva come parlare con loro, come accarezzarli, come trattarli. Io ero una bambina di città e non avevo la stessa dimestichezza, le invidiavo quella familiarità così semplice. Era così con i bambini e con i cani. Adesso un cane ce l’ho anch’io, o forse è lui che ha me, non lo so, non importa; e i cani nelle mie storie li metto appena posso.
La seconda parte dell’intervista a Beatrice Masini, interamente dedicata alla biografia di Louisa May Alcott (https://www.giulioperroneditore.com/prodotto/louisa-may-alcott/) sarà pubblicata nel numero 34 de Ilcorsaronero, Rivista Salgariana di Letteratura Popolare

No Comments