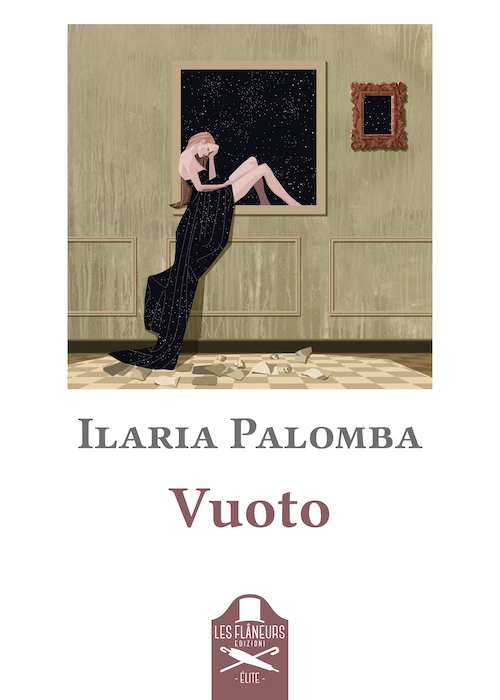
07 Dic Ilaria Palomba, “Vuoto”
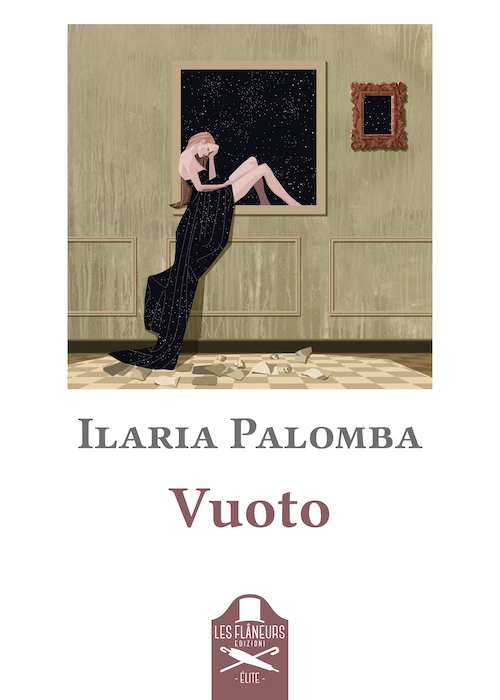 di Giorgio Galli
di Giorgio Galli
Negli anni Novanta del Novecento, fra la caduta del comunismo e quella delle Torri Gemelle, è avvenuto un fenomeno che potremmo definire “fine dell’immaginario”: il venir meno di ogni orizzonte d’attese in favore di un radicale adattamento alla realtà così com’è. Vivere senza orizzonti non era la norma per le generazioni nate prima degli anni Ottanta, e tantomeno per quelle venute al mondo nei primi sei decenni del Novecento; ma per la generazione nata a ridosso del cambiamento -negli anni Ottanta e primi anni Novanta- il passaggio è stato particolarmente traumatico, perché è coinciso con il crollo del gigantesco, e sia pur squallido, orizzonte d’attesa degli yuppie e l’inaugurazione di un modo di vivere giorno per giorno, che riempie la vita con la vita stessa e addirittura coincide con la sopravvivenza, in molti casi, per via di condizioni lavorative precarie o inesistenti, che bloccano sul nascere qualsiasi cosa somigli a un progetto di vita. Se la generazione che ha fatto la Resistenza ragionava in termini di classe dirigente indipendentemente dall’effettiva classe sociale di appartenenza, le generazioni odierne pensano in termini di fatalistica sottomissione a un potere invisibile anche laddove la loro vita ha il sapore di un privilegio economico e sociale che viene dai genitori e che è destinato ad estinguersi col trascorrere del tempo.
In Vuoto (Les Flâneurs, 2022), Ilaria Palomba mostra senza pudore le conseguenze della fine dell’immaginario in una ragazza dotata di energia, di immaginazione, di personalità. Dover agire senza un orizzonte la porta a un moto perpetuo di vita, a trascorrere da un’esperienza all’altra, sempre più estreme, con sempre più insoddisfazione, avendo come esiti quasi obbligati il disgusto di sé e del mondo, il senso di vuoto e noia, la droga. Più che un’autrice, Ilaria è un sintomo, e ciò che scrive non è un romanzo: è un referto. La sua scrittura completamente onesta, la sua prosa incandescente, priva di un centro unificatore, con gruppi di parole che aggettano dal discorso e poi nel discorso ritornano, rutilando nel grande fiume delle altre parole, questa scrittura della “bussola che va impazzita all’avventura”, questo romanzo senza struttura, che salta fra tempo e tempo, tra sonno e veglia, inconscio e realtà senza separare i vari piani, tutto questo costituisce l’autodenuncia di una generazione veramente perduta, che grida al mondo la sua inutile rabbia e la sua altrettanto inutile frenesia. Una scrittura che grida “Ecco com’è vivere senza orizzonti!” agli esseri umani che l’hanno preceduta nel mondo. L’autrice usa come un’arma di protesta la sua stessa figura e -nella vita- il suo stesso corpo desacralizzato, e lo urla alle generazioni carnefici, a quelle che le hanno tolto l’orizzonte, scippato l’immaginario. Ilaria Palomba è -in corpo e talento- la protesta vivente di gente costretta al cinismo senza averlo per temperamento, costretta a campare alla giornata quando voleva costruire un avvenire, a indossare maschere per non mostrare un volto reso fiacco dall’adattamento precoce alla realtà così com’è.
 Vi sono punti di contatto fra la scrittura autobiografica di Ilaria e quella di Paola Silvia Dolci, altra autrice di diari pubblici in cui si mescolano sogno e realtà, e in cui il moto perpetuo delle immagini e dei pensieri genera un analogo effetto di disorientamento, di perdita dei riferimenti. Entrambe le autrici mostrano una grande purezza e pulizia interiori nella loro capacità di offrirsi così onestamente al lettore; ma mentre Paola è scrittrice ironica e autoironica, e versa le sue fiale di dolore in gelide e brevi scudisciate di poesia e di prosa, Ilaria Palomba è scrittrice totalmente tragica: la presenza dell’ironia nel suo testo non è il dato prevalente. A livello formale, si avverte in entrambe l’influsso di comuni letture della poesia confessionale americana, ma, mentre in Paola tale influsso è mediato da una razionalità profonda -Paola è ingegnere oltre che scrittrice, poetessa e giornalista- in Ilaria la sofferenza si dà nuda, assoluta, senza vie d’uscita. Ciò avvicina la sua scrittura a quella di un’altra potente autrice contemporanea, Veronica Tomassini; ma Veronica, nata nel 1971, ha un pur doloroso orizzonte di vita che coincide con la sacralizzazione del tutto: la sua prosa è fatta di immobilità, di vortici emotivi che tornano su se stessi, che si cristallizzano nel cesello della lingua e finiscono per andare a comporre un’icona sacra, fascinosa nella sua visione scorticata e dura. Ilaria, nata nel 1987, incarna al meglio, con la sua scrittura incandescente, il tormento di chi è cresciuto suo malgrado nel dovere di essere cinico.
Vi sono punti di contatto fra la scrittura autobiografica di Ilaria e quella di Paola Silvia Dolci, altra autrice di diari pubblici in cui si mescolano sogno e realtà, e in cui il moto perpetuo delle immagini e dei pensieri genera un analogo effetto di disorientamento, di perdita dei riferimenti. Entrambe le autrici mostrano una grande purezza e pulizia interiori nella loro capacità di offrirsi così onestamente al lettore; ma mentre Paola è scrittrice ironica e autoironica, e versa le sue fiale di dolore in gelide e brevi scudisciate di poesia e di prosa, Ilaria Palomba è scrittrice totalmente tragica: la presenza dell’ironia nel suo testo non è il dato prevalente. A livello formale, si avverte in entrambe l’influsso di comuni letture della poesia confessionale americana, ma, mentre in Paola tale influsso è mediato da una razionalità profonda -Paola è ingegnere oltre che scrittrice, poetessa e giornalista- in Ilaria la sofferenza si dà nuda, assoluta, senza vie d’uscita. Ciò avvicina la sua scrittura a quella di un’altra potente autrice contemporanea, Veronica Tomassini; ma Veronica, nata nel 1971, ha un pur doloroso orizzonte di vita che coincide con la sacralizzazione del tutto: la sua prosa è fatta di immobilità, di vortici emotivi che tornano su se stessi, che si cristallizzano nel cesello della lingua e finiscono per andare a comporre un’icona sacra, fascinosa nella sua visione scorticata e dura. Ilaria, nata nel 1987, incarna al meglio, con la sua scrittura incandescente, il tormento di chi è cresciuto suo malgrado nel dovere di essere cinico.
A livello narrativo, Vuoto segue i ricordi, i pensieri e le esperienze oniriche di Iris, una giovane scrittrice romana di origini pugliesi, tra ricordi struggenti di amici scomparsi e reminiscenze atroci di violenze subite. A livello formale, la scrittura si caratterizza per la conservazione -pur nel visibile lavoro di decantazione- dello slancio originale di uno scrivere in diretta, diaristico, con la mano che corre sulla tastiera all’inseguimento del pensiero che si fa: è una scrittura che mostra la forma che si forma, e che a volte si traduce in un vasto flusso di parole, a volte si condensa in aforismi di cioraniana velenosità, in esercizi di scorticata sincerità intellettuale e morale. Si avvertono le influenze di Joyce e di Musil: Vuoto non è un romanzo di trama, ma un’opera in cui protagonista è il pensiero: un pensiero in continuo movimento, il cui agitarsi è determinato da un criterio musicale, secondo le spire di un fraseggio vorticoso e wagneriano. Più che un romanzo, definirei quello di Ilaria un poema: il vasto tremendo poema del vivere senza orizzonti.

No Comments