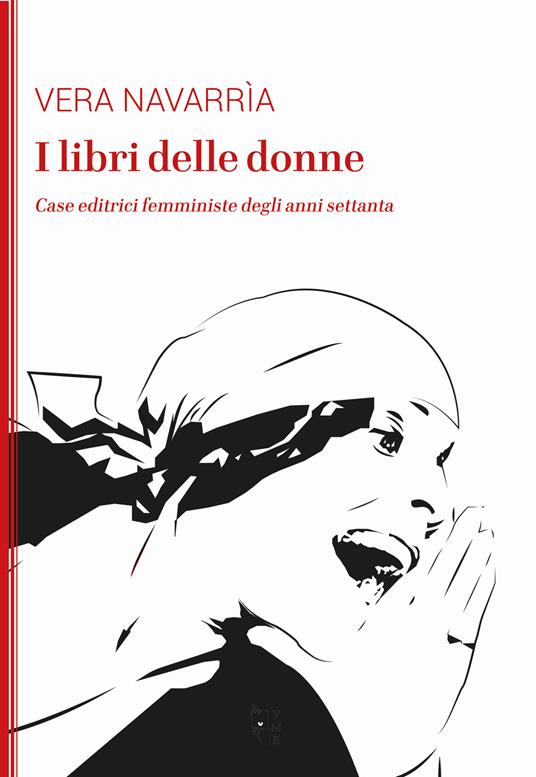
03 Feb Editoria femminista e lavoro culturale. Un’intervista a Vera Navarria
di Giada Scuto
Il successo degli anni settanta, che bisognerebbe riscoprire, custodire e difendere, è la conquista, per le donne, del diritto di parola. Perché fosse raggiunto le case editrici femministe hanno giocato un ruolo fondamentale; eppure le loro vicende non sono popolari né tra i lettori comuni, né tra le femministe, né tra i professionisti dell’editoria (Vera Navarria)
I libri delle donne. Case editrici femministe degli anni settanta (Villaggio Maori Edizioni, 2018) è il saggio con cui Vera Navarria, autrice catanese specializzata in cultura e storia del sistema editoriale, riempie il vuoto che la storiografia convenzionale ha lasciato riguardo al contributo portato dai collettivi femministi al mondo editoriale, un lavoro che è stato soprattutto una pratica politica, e che per diversi aspetti ci riguarda ancora.
Il libro di Navarria è un viaggio geografico e cronologico dentro le storie di lotta e impegno collettivo che hanno portato alla fondazione delle prime case editrici femministe europee – dal Regno Unito all’Italia passando per Francia e Germania – capace di riportare alla luce un passato di militanza politica e lavoro culturale portato avanti autonomamente dalle donne. Si tratta di un passato che rimane ancora in ombra quando si parla di storia di editoria, per di più in un paese in cui, secondo i dati ISTAT, sono proprio le donne, ad oggi, le maggiori acquirenti nel mercato del libro.
La ricerca che l’autrice ha intrapreso non è tanto letteraria (per quanto, leggendolo, difficilmente i margini delle pagine non si riempiranno di annotazioni, nomi di autrici e titoli che hanno segnato la storia della letteratura), quanto più concentrata sulle dinamiche che hanno determinato la nascita, il mantenimento, e poi anche la chiusura delle case editrici femministe. Quello dell’editoria femminista, infatti, non è mai stato un lavoro finalizzato al profitto bensì all’ampliamento della lotta politica, alla presa di coscienza della condizione femminile e delle influenze esercitate sulle donne dalla società.
Fondate principalmente da gruppi di donne militanti, le case editrici femministe nascevano con l’idea di rovesciare il sistema editoriale tradizionale, basato su una struttura capitalista e patriarcale, creando nuovi modelli imprenditoriali anticonvenzionali, autogestiti e indipendenti. L’etica di questo tipo di lavoro culturale si è però rivelata insostenibile a fronte delle regole di un mercato che si faceva sempre più competitivo ed escludente. In Italia, infatti, nessuna delle case editrici fondate in quegli anni è ancora attiva: la maggior parte ha chiuso i battenti a seguito di crisi finanziarie o al crollo del sistema organizzativo, unica eccezione può definirsi forse il caso de La Tartaruga, marchio che oggi si è trasformato in una collana, diretta da Claudia Durastanti per La Nave di Teseo.
Negli anni settanta il lavoro delle donne che gravitavano attorno alle case editrici femministe era del tutto volontario, le case editrici si reggevano su finanziamenti delle socie e le somme ricavate dalle vendite venivano immediatamente riutilizzate per portare avanti l’obiettivo originale: pubblicare e tradurre scritti politici, romanzi, saggi, poesie e scritti autobiografici delle donne. Reggendosi su un’organizzazione non gerarchizzata e non sistematica, l’editoria femminista non è riuscita ad essere fonte di informazione su sé stessa.; è per questo che libri come quello di Navarria possono diventare guide preziose verso una storiografia che va ricostruendosi – non senza fatica – nel presente.
Grazie al materiale conservato l’autrice ricostruisce la storia delle principali case editrici femministe, dalle britanniche Womens’s Press e Virago Press – a cui dobbiamo, rispettivamente, la pubblicazione di testi importantissimi come I know why the caged bird sings di Maya Aneglou (1982) e The Color Purple di Alice Walker – alla francese Éditions de Femmes. Da quest’ultima prenderà il nome la casa editrice femminista Edizioni delle Donne, nata nel 1976 appena un anno dopo La Tartaruga, fondata nel 1975 da Laura Lepetit, a cui dobbiamo la prima edizione italiana de Le tre ghinee di Virginia Woolf, per fare soltanto un esempio.
L’editoria femminista di quegli anni, di cui oggi si ricorda molto poco, ha aperto la strada a quelli che successivamente verranno annoverati come casi editoriali o capolavori della letteratura del Novecento, oltre ad aver permesso alle donne di riappropriarsi della propria voce, di diffonderla e di creare consapevolezza rimanendo su un terreno libero e partecipato, aperto alla sperimentazione e alle idee talvolta sconvenienti ma rivoluzionarie.
 Rispondendo ad alcune domande, Vera Navarria ha raccontato quali sono stati gli obiettivi e i retroscena della ricerca dietro I libri delle donne.
Rispondendo ad alcune domande, Vera Navarria ha raccontato quali sono stati gli obiettivi e i retroscena della ricerca dietro I libri delle donne.
Giada: Nell’introduzione del libro parli dei limiti pratici che hai incontrato durante la tua ricerca, dalla mancanza di traduzioni alla difficile accessibilità delle fonti. In anni come questi, in cui soprattutto le case editrici indipendenti si stanno impegnando a ripotare alla luce testi femministi attraverso ripescaggi e traduzioni, perché secondo te è ancora così complesso fare luce sulla storia dell’editoria femminista in Italia?
Partiamo col dire che ricostruire la storia dell’editoria femminista nel nostro paese è sicuramente difficile, ma non impossibile. Quello che è mancato e manca ancora è un interesse forte e duraturo, e dipende principalmente dal fatto che la nostra è ancora una società patriarcale. Quindi la prima difficoltà è di tipo culturale. Poi esistono difficoltà pratiche: proprio perché nella stragrande maggioranza dei casi si trattava di piccole imprese, basate sul volontariato e la militanza, le case editrici femministe non hanno lasciato molta memoria documentale, a parte i loro libri. A volte è difficile reperire anche quelli. Potrei raccontare diversi episodi occorsi durante la mia ricerca, ma in fondo l’immagine più vivida e che la riflette meglio sono le ore passate in biblioteca, l’emozione provata nel tenere in mano quei libri che mi restituivano il senso di avere un passato, una storia che mi precede. È un’esperienza che consiglio di fare.
G.: Nel capitolo in cui tratti la storia di Éditions de femmes, descrivi la loro posizione “in aperta polemica con l’impresa editoriale classica”, ideale condiviso anche dalle case editrici femministe italiane, prima su tutte Rivolta Femminile. Il tentativo di “sfuggire al compromesso capitalista” e creare un modello aziendale alternativo è stato messo in atto anche dalle librerie delle donne negli Stati Uniti, dove per ovviare al problema dei costi della grande distribuzione, visti anche i pochi fondi a disposizione, le donne caricavano i libri nei bagagliai delle auto e fornivano autonomamente le librerie. Il lavoro editoriale e la militanza femminista erano fusi nello stesso impegno, e spesso le case editrici resistevano grazie al volontariato. Come vedi, oggi, il confine tra lavoro culturale e militanza?
Molto sottile. Da questo punto di vista credo che poco sia cambiato dagli anni ’70 a oggi. Chi fa lavoro culturale, come chi fa militanza, interpreta la propria come una vocazione. Dunque non di rado accetta sacrifici, in termini economici, contrattuali, di vita, che non accetterebbe in qualsiasi altro settore. Perché dal suo impiego riceve una soddisfazione maggiore, che gli fa spesso credere, almeno per un periodo, che quei sacrifici siano giusti. Io ho abbandonato il mestiere dell’editoria per questa ragione, anche se mi sono lanciata in un’altra professione ad alto fraintendimento vocazionale che è quella dell’insegnante.
G.: Nel tuo libro scrivi che nell’editoria femminista europea degli anni Settanta le autobiografie occupavano da un terzo a metà dei titoli in catalogo. Il dibattito sull’autobiografismo nella letteratura contemporanea è in fermento; e più le pubblicazioni sono recenti, più sembrano oltrepassare i limiti imposti dai canoni letterari dominanti che paiono difficili da superare (evidentemente più per chi si occupa di critica che per le lettrici e i lettori). L’autrice statunitense Melissa Febos in Questa mia carne. Scrivere di sé come atto radicale (Nottetempo, 2024) sostiene che il pregiudizio verso la scrittura autobiografica faccia parte di un meccanismo sessista, che si fonda sul falso binario tra ciò che è emotivo (femminile) e ciò che invece è intellettuale (maschile) ed è volto a subordinare il primo. Credi che pubblicare storie di donne che scrivono di sé sia ancora un atto politico?
Sempre. Naturalmente esistono molti modi per scrivere di sé e l’autobiografia non è l’unico. Ciò che credo sia davvero importante, è la presenza nelle nostre narrazioni di personaggi femminili fuori dallo stereotipo.
G.: Le librerie delle donne che esistono ancora oggi sono veri e propri presidi di resistenza, in cui è possibile trovare testi poco conosciuti – oltre a quelli molto noti – che illuminano un passato da conoscere. Dove manca di più oggi in Italia, una libreria delle donne?
Al Sud. Ma più che una libreria delle donne, direi che a mancare è una libreria femminista. I tempi ci hanno dimostrato tutti i limiti di un pensiero biologista o essenzialista. Comunque va detto che oggi diverse librerie indipendenti, anche al Sud naturalmente, offrono una buona scelta di testi femministi e lo scaffale “Femminismo” si trova anche presso alcune librerie di catena, il che è sicuramente un bene.
G.: Ci sono dei libri o delle case editrici che ti piacerebbe consigliare?
Dopo la pubblicazione del libro sono nati alcuni progetti interessanti, che mi fa piacere segnalare. Somara! Edizioni per esempio è una casa editrice di Ferrara che ha pubblicato una biografia di Anne Lister, l’inglese che ai primi dell ‘800 visse come una donna apertamente lesbica, documentando le proprie relazioni nei suoi diari (a proposito dell’importanza del racconto di sé). Poi c’è Tamu Edizioni, un progetto importantissimo. Hanno tradotto bell hooks, rendendo disponibile al pubblico italiano molto del suo pensiero. Anche se non pubblica solo donne, 8 Edizioni è una casa editrice con un catalogo ricco di autrici. E infine segnalo Rina edizioni, che si è data la missione di riportare alla luce le scrittrici del passato. Poiché molte di loro sono italiane, l’opera di questa casa editrice risulta particolarmente interessante per la riscoperta e la fondamentale costruzione di un canone italiano che non escluda le donne.
Foto gentilmente concesse da Vera Navarria.

No Comments