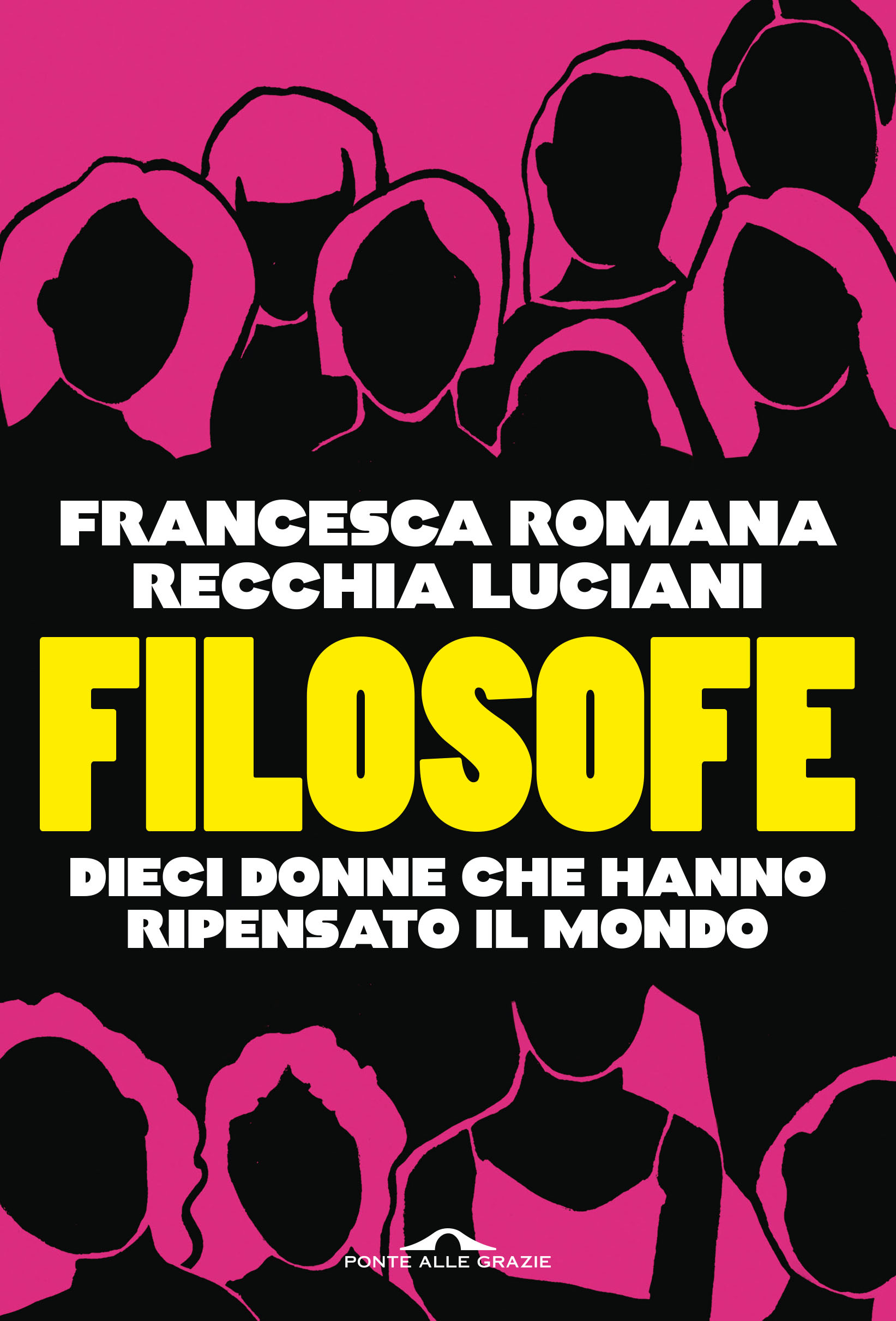
07 Mar Filosofe. Dieci donne che hanno ripensato il mondo. In dialogo con Francesca Romana Recchia Luciani
a cura di Ivana Margarese e Paola Nitido

Filosofe. Dieci donne che hanno ripensato il mondo di Francesca Romana Recchia Lucianiracconta dieci protagoniste del pensiero da Lou Salomé a María Zambrano, da Hannah Arendt a Simone de Beauvoir, da Simone Weil a Ágnes Heller, da Carla Lonzi a Audre Lorde, da Silvia Federici a Judith Butler.
Il testo guida alla scoperta delle storie e della visione del mondo di queste diverse figure femminili accomunate dal desiderio di mettersi in gioco, di ripensare il mondo, di abitare uno spazio nel ‘sapere dei saperi’ con la propria ‘vita filosofica’.

Ivana: Questo libro è un contributo prezioso per la storia della filosofia, che purtroppo ancora adesso fatica – ad esempio a scuola – a raccontare il pensiero delle donne. Da quanto tempo immaginava di scrivere questi suoi “frammenti di discorso amoroso” e filosofico?
Questo libro ha un precedente in un manuale per i licei che si chiama Saperi di genere (D’Anna Editore ndr.) edito nel 2017, un testo dedicato alle rivoluzioni femministe che aveva un breve apparato didattico ed era pensato, quindi, come strumento per la scuola per raccontare le evoluzioni della storia dei femminismi a partire fondamentalmente da Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft, ovvero subito dopo la rivoluzione francese. Saperi di genere aveva un chiaro obiettivo didattico cioè era stato concepito come un piccolo manuale di storia dei femminismi. Filosofe, invece, ha una gestazione diversa perché nasce da una certa “stanchezza” nei confronti del canone della storia della filosofia tradizionale che a prescindere dalle filosofe femministe – infatti le “mie” dieci filosofe non sono tutte femministe in senso stretto – ignora quasi del tutto le donne.
Chi sfoglia un manuale di storia della filosofia per i licei incontra soltanto nel terzo volume Hannah Arendt e Simone Weil: loro sono quasi un’eccezione che, come spesso accade, conferma la regola: tutti maschi e due donne che per ragioni imperscrutabili sono entrate nell’empireo della filosofia.
Ci viene pertanto proposto un modo illegittimo e parziale di raccontare la storia del pensiero filosofico: le donne peraltro per secoli non hanno avuto accesso all’istruzione – un divieto che è uno strumento di dominio – e tanto meno a un sapere considerato il più elevato. Il primo dei diritti rivendicato è stato proprio quello all’istruzione da Mary Wollstonecraft nel suo Rivendicazione dei diritti della donna del 1792.
 Paola: Le dieci filosofe di cui ha scritto costituiscono un canone altro rispetto ai percorsi di storia della filosofia che studiamo, molto spesso, all’Università e a scuola. È possibile immaginare un canone integrato che consideri le filosofie insieme ai filosofi? Sarebbe importante, per esempio, studiare Lou Salomé quando si incontrano Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud. E tutte le altre filosofe dalla storia antica a quella contemporanea.
Paola: Le dieci filosofe di cui ha scritto costituiscono un canone altro rispetto ai percorsi di storia della filosofia che studiamo, molto spesso, all’Università e a scuola. È possibile immaginare un canone integrato che consideri le filosofie insieme ai filosofi? Sarebbe importante, per esempio, studiare Lou Salomé quando si incontrano Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud. E tutte le altre filosofe dalla storia antica a quella contemporanea.
Il problema è proprio il misconoscimento del pensiero delle filosofe. Noi conosciamo Lou Salomé o Simone de Beauvoir fondamentalmente nella relazione con gli uomini; Salomé in particolare per il suo rapporto con Nietzsche e con Freud, Simone de Beauvoir per essere stata la compagna, tra le altre cose tradita ripetutamente, di Jean Paul Sarte.
La rappresentazione che ne viene fuori è quella di figure ancillari che non contano sotto il profilo della produzione teorica, anzi si ignorano in maniera esplicita i loro testi, ma vengono associate al rapporto con altri pensatori. In realtà, la storia è ben diversa: Nietzsche riconosce un ruolo fondamentale a Salomé nell’elaborazione del proprio pensiero, in particolare per Così parlò Zarathustra, mentre Freud la considerava un’interlocutrice assolutamente geniale. É un’operazione di rimozione, una cancellazione che implica il misconoscimento, ovvero la negazione di una soggettività altra.
Ivana: Hannah Arendt è una delle pensatrici più importanti del Novecento. A dispetto di ciò lei ha rifiutato per sé stessa l’appellativo di filosofa e sottolineava di non potere amare un popolo in astratto ma di riuscire a amare solo le persone reali. Fondamentale peraltro è stato per lei durante tutta la vita il confronto – in gran parte epistolare – con la scrittrice americana, grandissima sua amica, Mary McCarthy, che peraltro la ricorda nel giorno del suo funerale con parole profonde e ricche di emozione. Come descriverebbe il rapporto tra queste due donne e lo stimolo costante che hanno ricevuto l’una dall’altra?
Le filosofe sono riscoperte dalle donne. A Simone Weil, per esempio, si è arrivate soprattutto grazie al lavoro delle filosofe che l’hanno amata, io sono fra loro, e che poi hanno scritto tanto su di lei. Quindi, la storia del pensiero ha considerato Simone Weil grazie alle donne che l’hanno studiata.
Il caso di Hannah Arendt è, invece, quello un’intellettuale a tutto tondo. Contrariamente ad altre donne filosofe, che non sono state accademiche (tra le donne prese in considerazione dal mio libro quattro sono accademiche, le altre non lo sono o lo sono in settori diversi dalla filosofia, come nel caso di Audre Lorde), Arendt è stata sia una filosofa accademica sia un’intellettuale riconosciuta. Lei è soprattutto una teorica politica, una filosofa della politica e sicuramente in questo ha giocato moltissimo il ruolo di intellettuale militante. Ricordiamoci, in particolare, il processo a Adolf Eichmann e la sua tesi della “banalità del male” che l’è costata una censura spaventosa sia da parte della comunità ebraica americana che israeliana.
In merito al rapporto con Mary McCarthy è la dimostrazione, molto cara alle donne filosofe, della relazione fra pubblico e privato. Le donne filosofe, come scrivo spesso nel libro, rifiutano la dimensione astratta del pensiero e pensano con tutto il corpo, perché l’anima e il corpo non sono separate, sono un unico ambito in cui si sviluppa il pensiero. Dunque, il rapporto con questa amica carissima, con cui lei si confida e a cui racconta anche tutti i suoi dubbi teorici, è sia intellettuale che affettivo. Così come si è parlato del rispecchiamento in negativo del femminile tramite il maschile, nel caso di Arendt e McCarthy, invece, c’è un rispecchiamento positivo poiché si tratta del dialogo fra due intellettuali “gemelle”, che riconoscono l’una il lavoro dell’altra. In conclusione, ciò che ha funzionato molto per restituire alle donne valore è stato proprio il lavoro delle donne grazie anche ai femminismi che hanno consentito di riconoscere il loro impegno intellettuale.
 Paola: A proposito di Carla Lonzi scrive che la sua è “la posizione teorica più solida espressa in quegli anni e la sua elaborazione teorica e concettuale resta una pietra miliare del femminismo che si lascia alle spalle la logica emancipazionista e paritaria, in cui ancora si iscriveva in parte la prospettiva di Simone de Beauvoir, per puntare invece, tramite l’affermazione della differenza, direttamente alla liberazione della donna, il ‘soggetto imprevisto’ che intende finalmente, dopo aver subito per millenni la propria cancellazione, fare la sua comparsa da protagonista sulla scena della storia”. In che modo le prospettive di Lonzi e Beauvoir in merito alla liberazione della donna differiscono e come queste differenze si riflettono nelle loro analisi filosofiche?
Paola: A proposito di Carla Lonzi scrive che la sua è “la posizione teorica più solida espressa in quegli anni e la sua elaborazione teorica e concettuale resta una pietra miliare del femminismo che si lascia alle spalle la logica emancipazionista e paritaria, in cui ancora si iscriveva in parte la prospettiva di Simone de Beauvoir, per puntare invece, tramite l’affermazione della differenza, direttamente alla liberazione della donna, il ‘soggetto imprevisto’ che intende finalmente, dopo aver subito per millenni la propria cancellazione, fare la sua comparsa da protagonista sulla scena della storia”. In che modo le prospettive di Lonzi e Beauvoir in merito alla liberazione della donna differiscono e come queste differenze si riflettono nelle loro analisi filosofiche?
Simone de Beauvoir è una pioniera. Nel 1949 scrive Il secondo sesso, testo fondamentale per comprendere la condizione femminile. La differenza con Lonzi è innanzitutto temporale dal momento che Beauvoir scrive quaranta anni prima con una straordinaria potenza di analisi; Lonzi riprenderà a modo suo una questione centrale di Beauvoir rivendicando la natura della differenza sessuale.
Il tema del “soggetto imprevisto” è declinato in un modo differente; per Beauvoir quel soggetto non è ancora descritto come imprevisto dal momento che viene analizzato come soggetto irregimentato nella storia della cultura e che per questo intende rivendicare i propri diritti. Carla Lonzi fa un salto filosofico rilevante criticando proprio il paradigma culturale che ha assoggettato metà dell’umanità. Entrambe le filosofe manifestano grande coraggio, teorico e militante. Inoltre Beauvoir nella sua opera mette in discussione il concetto di genere, ovvero la non coincidenza tra genere e sesso – che corrisponde al grande tema di Judith Butler. La rivendicazione di Carla Lonzi è una rivendicazione politica: il soggetto femminile esiste e pretende di essere considerato come differente rispetto al maschile.
 Ivana: Tra le filosofe del tuo libro c’è Ágnes Heller. Qual è a tuo parere il suo lascito più importante all’interno del dibattito etico contemporaneo?
Ivana: Tra le filosofe del tuo libro c’è Ágnes Heller. Qual è a tuo parere il suo lascito più importante all’interno del dibattito etico contemporaneo?
Mi affascina di Heller il fatto che è la più neutra dal punto di vista del posizionamento tra le filosofe. Ancor di più di Arendt, la quale rifiutava l’attributo di femminista, ma Heller è più neutra nel senso di non femminista perché lei fa un ragionamento che aspira all’universale. Inoltre, in Heller c’è un grande tema del libro, l’intreccio tra filosofia e vita, che percorre tutto il testo a dimostrare che le donne filosofe non sono solo interessate all’astrazione. Rilevante è notare quanto queste filosofe abbiano messo la loro vita concreta dentro il pensiero. Succede a Heller, che è un’esiliata, e a Maria Zambrano che vive quasi tutta la sua vita all’estero. Le scelte politiche non sono staccate dal pensiero, ma sono vissute, anzi pagate, con la vita. Dunque, il pensiero di Heller mi interessa molto come analisi assolutamente disinibita di tutti i meccanismi di oppressione sociale, tra cui i totalitarismi, tema che lei ha in comune con Hannah Arendt.
Ivana: Non tutte le filosofe di cui parli si sono riconosciute nel “femminismo”, seppure hanno fatto scelte di grande libertà. Nell’introduzione al testo scrivi puntualmente del ruolo tradizionale dato alle donne condizionate da una parte da rigidi canoni di bellezza e dall’altra dall’invenzione dell’istinto materno. Queste rappresentazioni hanno finito per imprigionare la stragrande maggioranza delle donne in strutture familiari asimmetriche, senza alcuna possibilità di riscatto o emancipazione. Ecco che raccontare queste dieci pensatrici ricostruisce una genealogia nascosta e cancellata che può essere preziosa per affrontare con spirito critico le nostre sfide quotidiane. Quali sono a tuo parere i condizionamenti che ancora oggi le donne in Italia sono costrette a fronteggiare?
Non tutte le filosofe di cui ho scritto erano femministe o sono state femministe, ma tutte devono in qualche modo quello che hanno al femminismo. Lou Salomé non può essere considerata una femminista, così come Arendt, Weil e come la stessa Heller – che scrive un testo dedicato alle rivendicazioni dei diritti delle donne, ma non ha questo particolare interesse – così come Zambrano che tutto sommato non ha alcuna attinenza diretta col femminismo. Tuttavia grazie a esso queste autrici hanno non soltanto potuto prendere parola, ma anche essere studiate e apprezzate per il loro pensiero originale e per certi versi sovversivo. Tengo molto in questa costellazione di ritratti a Audre Lorde perché è la prima volta che credo compaia in un testo di filosofia. É sempre stata letta come poeta, come studiosa del razzismo, militante dell’antirazzismo e del femminismo, come teorica politica ma non come filosofa. Io invece rivendico il taglio filosofico di Audre Lorde.
Fondamentale è inoltre per me il ruolo sia di Silvia Federici che di Judith Butler le quali hanno dato un contributo fondamentale al pensiero femminista. Silvia Federici è illuminante nello spiegare la differenza tra lavoro produttivo e lavoro riproduttivo. Le donne hanno potuto dedicarsi al cosiddetto lavoro produttivo, cioè il lavoro fuori di casa, soltanto quando il sistema capitalistico e patriarcale ha avuto bisogno del lavoro delle donne. Fino a quel momento le donne avevano potuto svolgere esclusivamente un lavoro riproduttivo, indorato col tema della cura e del destino materno e familiare. Questo lavoro riproduttivo non era altro che lavoro gratuito prestato al sostentamento del sistema patriarcale e capitalistico. Lavoro, peraltro, totalmente non riconosciuto. Di questo si è occupata Federici, già a partire dagli anni 80’, fino al testo Calibano e la strega. Le donne, il corpo, e l’accumulazione originaria.
Paola: Nella nostra contemporaneità, invece, qual è il posto delle filosofe? Quali passi possiamo compiere per garantire una maggiore inclusione e costruire un saldo riconoscimento delle filosofe nel futuro?
Questo libro è un tentativo di incoraggiare le giovani filosofe, le ragazze che studiano con passione la filosofia, anche perché rappresentano molto spesso la maggioranza nelle nostre aule universitarie. Volevo dare loro spazio contrastando un canone della storiografia filosofica che cancella le donne. Penso che questo libro serva non solo a mostrare dei modelli, originali come nel caso di Lorde, illuminanti come nel caso di Judith Butler, ma possa essere un segnale di un percorso aperto che rompe con quella tradizione. Va inoltre non rimosso, ma coltivato il legame fra vissuto e teoria, così come fra corpo e pensiero, poiché spesso si dà un’immagine della filosofia come pura idealizzazione e astrazione, che fatalmente cancella la nostra natura corporea e relazionale. La filosofia ha un corpo, e nel mio caso è un corpo di donna.


No Comments