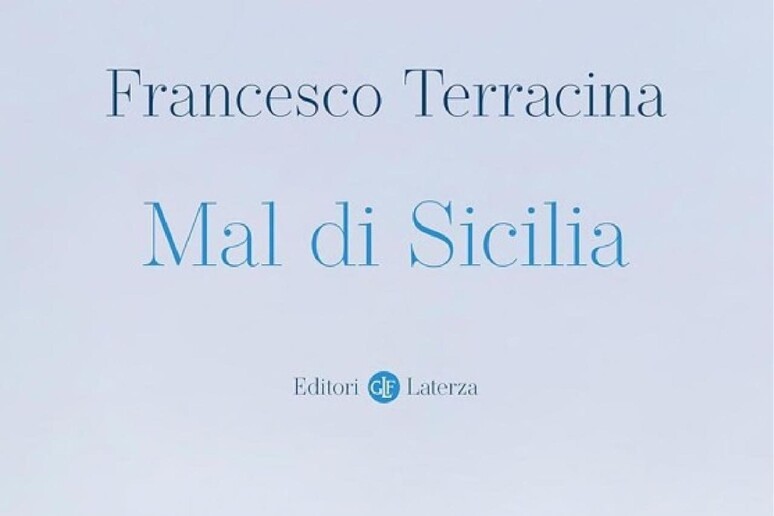
03 Apr Mal di Sicilia. In dialogo con Francesco Terracina
a cura di Ivana Margarese

Come è nato il progetto di questo libro? Da quanto tempo avevi in mente di scrivere su “Mal di Sicilia”, su questa tensione tra l’impulso di allontanarsi e il desiderio di restare che vive chi abita l’isola?
In Sicilia la vita è altrove. A noi isolani vengono offerti beni che esitiamo ad accettare: il mare, il sole, la natura, elementi che non sappiamo governare e dei quali ci vendichiamo. Ciò che abbiamo è anche quello che ci manca. Basta vedere cosa abbiamo fatto col nostro suolo, come abbiamo devastato la costa, segando il ramo sul quale siamo seduti. Fino all’adolescenza pensavo che il lavoro, la cura, fossero soltanto fatica punitiva, che la felicità del fare ci escludesse. Chi non si adegua, parte per poi tessere la tela del ricordo. Ecco, la Sicilia come ricordo sembra l’unico modo per pacificarsi con essa. Guardiamo da lontano al mondo offeso, per dirla con Elio Vittorini, per sollevarlo da questa condizione. Il ritorno è un atto riparativo, carico di furore (qualche volta) e sottomesso alla nostalgia (il più delle volte). Forse questo libro si è scritto da solo, attraverso alcune figure che hanno scelto di partire (anche solo mentalmente) o di restare (non solo per legge di nascita ma, appunto, per scelta), vivendo la Sicilia, da fuori o in presenza, attraverso il ricordo, senza soggiacere alla furia della contingenza.
Il primo capitolo di Mal di Sicilia è dedicato a Filicudi e a Gisbert Lippelt, un tedesco che a poco più di vent’anni ha deciso di trasferirsi sull’isola e vivere in una grotta. A cosa è dovuta questa tua scelta?
Alla gratitudine nei confronti di un’altra cultura, capace di comunicare a noi tentennanti isolani, sempre sul limite tra la terra e l’acqua, che la libertà di fare della propria vita quello che si crede è un valore assoluto. Gisbert si è affrancato dai bisogni superflui indotti dal mondo, scegliendo per sé il più superfluo dei bisogni: la contemplazione.

Ho letto il tuo libro come un insieme di frammenti di un discorso amoroso nei confronti della Sicilia e delle figure di outsider che l’hanno abitata, tra loro Goliarda Sapienza, raccontata anche in relazione allo spirito della Sicilia orientale, a un’arte della gioia che sembra essere ignota nella sponda opposta. Potresti dirmi qualcosa al riguardo?
Goliarda Sapienza combina un’educazione anarchica con un carattere ribelle. Diffida di tutto ciò che appare definito e il suo essere outsider non è un’etichetta utile a fare commercio delle idee. Sta ai margini, sul serio, insieme a Modesta, l’esplosiva protagonista dell’Arte della gioia. Credo che lei e Guido Morselli siano stati gli autori più rifiutati dall’editoria italiana e i meno allineati, almeno ai gusti di quel periodo. Il suo essere catanese… L’Est è il luogo in cui nasce il sole, l’infanzia della luce, che non conosce ancora la stanchezza del tramonto. Palermo ascolta il racconto del giorno e si incupisce. “Nunc et in hora mortis nostrae. Amen”. ‘’Ed eccovi me a quattro, cinque anni, in uno spazio fangoso che trascina un pezzo di legno immenso”. Sono gli incipit del Gattopardo (la recita del rosario), e dell’Arte della gioia.
Elio Vittorini è uno degli scrittori di cui parli, con ammirazione e cura, anche richiamando la nota questione del suo rifiuto di pubblicare Il Gattopardo per Einaudi. Qual è il tuo profilo di Vittorini?
Isolano e siracusano, uomo di mare, ha dato dimensione letteraria a una Sicilia poco talattica, quell’entroterra dei feudi e delle miniere che oggi si svuota per inseguire il pane, nella terra che fu del grano e delle messi. È l’uomo che ha innovato la lingua e ha tolto il monopolio delle belle lettere agli “scrittori laureati”. Vittorini non sapeva che farsene del successo, si è reso la vita difficile. La mancata pubblicazione del Gattopardo è ancora considerato un errore imperdonabile. Ma quel testo nulla aveva a che spartire con la collana einaudiana dei “Gettoni” che dirigeva con l’intento di imboccare una nuova strada per la narrativa italiana. Non discuto il valore del testo di Tomasi di Lampedusa (e credo che non lo ignorasse neanche lo scrittore siracusano), che infatti lo segnalò alla stessa casa editrice per la collocazione in un’altra collana. Poi sappiamo com’è andata. Partigiano, antifascista, misurò la febbre all’Italia e alla sinistra e fu subito sospettato di eresia, canzonato da Togliatti. Vittorini, in fondo, restò sempre l’anarchico che era da adolescente. Irrequieto, irrisolto. E non è un caso che l’ultimo libro, uscito postumo, Le città del mondo, forse è il suo lavoro più riuscito. Guarda caso, un libro incompiuto.

Un’autrice che il tuo libro mi ha spronato a conoscere meglio è Laura Di Falco, scrittrice straordinaria anche nel rendere attraverso la decadenza dell’aristocrazia di Ortigia un passaggio storico fondamentale. Eppure in pochi conoscono il suo talento, che andrebbe certamente ricordato.
Pur parlando d’altro, Di Falco ha anticipato il miraggio industriale della Sicilia: le raffinerie, la chimica accanto agli agrumi e alle bellezze archeologiche, mentre le classi abbienti accoglievano il nuovo con l’ansia di riposizionarsi, con l’unico interesse di non perdere alcun privilegio, in barba a ogni spirito di comunità. Oggi la crisi è dichiarata, ma sessant’anni fa Laura Di Falco, nel segnalare una società guasta (come il pesce portato a tavola per i commensali ne L’inferriata), stigmatizzava un grave errore di politica industriale, di cui non s’accorse Vittorini. Lei l’ha fatto e l’essere donna non l’ha aiutata. Finì nel nulla anche un approccio epistolare con Leonardo Sciascia.

In Mal di Sicilia si incontra anche la figura elegante e fiera di Livia De Stefani. Com’è avvenuto il tuo incontro con questa scrittrice?
Non improvvisamente. De Stefani era amica di Marcello Cimino e Giuliana Saladino (altra scrittrice eccellente), una coppia nella vita e nella professione: avevano lavorato entrambi al giornale L’Ora dove continuavano a essere di casa e dove lavoravo anch’io, a quel tempo poco più che apprendista e dunque pronto a cogliere gli spunti offerti dai maestri. Fu così che lessi La mafia alle mie spalle, l’ultimo, sorprendente libro di De Stefani. Negli anni successivi rimediai al ritardo leggendo il resto della sua produzione e scoprendo, per esempio, che già nel romanzo La vigna di uve nere, credo sia del ’53, il tema della mafia era ben presente, secondo una lettura non ovvia per quel tempo. Sempre in tema di soprese, mentre scrivevo il libro appresi, con qualche decennio di ritardo, che Claudia Mirto, mia collega al giornale, era nipote di De Stefani. Insomma, tutto portava alla scrittrice andata via dalla Sicilia quando era poco più che adolescente. De Stefani sosteneva che il periodo della sua attività letteraria era coinciso con “l’era delle sciamannate” e lei, donna di grande eleganza, era in qualche modo stata messa da parte. Ma secondo me la ragione più profonda stava nell’essere troppo in anticipo sui tempi.
Infine ti chiedo di parlare del pittore Tino Signorini, figura affascinante che con il suo naturale riserbo racconta bene parte di una città come Palermo, che vive anche di sottrazioni e luoghi sospesi.
Un giorno capitai alla galleria Elle Arte, in via Ricasoli, a Palermo, per visitare una mostra di Signorini che non conoscevo personalmente. In una delle stanze incontrai un signore magro, alto, un po’ stralunato che dava una sommaria occhiata alle tele esposte soltanto un giorno prima. Attaccai discorso e gli dissi: “Però, quanto è bravo questo pittore!”. “Crede?”, mi rispose lui. E si dileguò. Poco dopo appresi dalla gallerista che quel signore era Tino Signorini. Quando l’arte esprime qualcosa di vero, la prima domanda che si fa chi la guarda è: com’è che non l’ho capito prima? Signorini dà questo brivido. La Palermo scalcinata, buia, descrive la biografia della città del dopoguerra, le sue ferite mal curate, le sue suggestioni involontarie. I luoghi di Signorini sono cadenti, spopolati, mai oleografici, sottratti al cliché dell’Isola felice senza cedere alla tentazione della denuncia. Stanno lì, sulla tela, scabri e nudi, fuligginosi come un Sud a luci spente.


No Comments