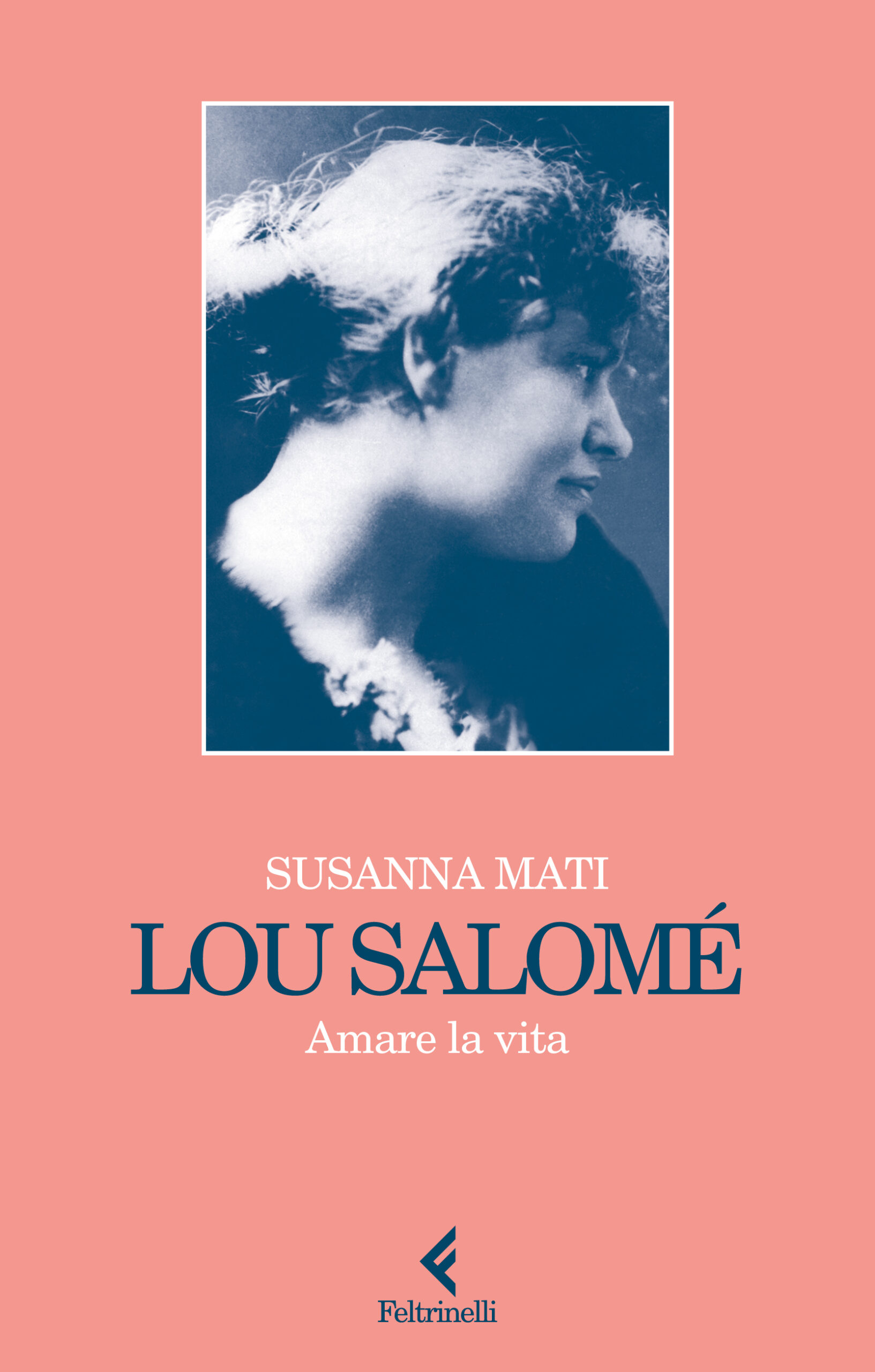
01 Apr Lou Salomé. Amare la vita.
7
di Ugo Morelli
“Lascia accaderti ogni cosa: bellezza e terrore”
[Lass dir Alles geschehn: Schönheit und Schrecken]
Rainer Maria Rilke, Libro della vita monastica
Accade raramente che una filosofa e scrittrice entri, alla maniera di Susanna Mati, con passo lieve e a piedi scalzi nel mondo di un’altra persona, tanto più se irriducibile, inaudita e ricchissima, come Lou Andreas Salomé. In verità nel suo caso era già accaduto con Nietzsche [Friedrich Nietzsche. Tentativo di labirinto, Feltrinelli 1917], e con le introduzioni, veri e propri saggi, alle opere di Hölderlin, Novalis, Platone, fino al delicato e insinuante Ninfa in labirinto [Moretti&Vitali, 2021].
La pratica esplorativa dei labirinti mentali ed esperienziali è parte dello stile di Susanna Mati e ancor prima della sua raffinata sensibilità di studiosa e pensatrice. Quello stile è in grado di codificare e restituire l’anima dei testi e delle autrici e degli autori di cui si occupa. Così come accade con l’attuale Lou Salomé. Amare la vita, appena pubblicato da Feltrinelli [Milano 2025]. Ora, qui, nel caso di Lou Salomè, sembra accadere qualcosa di più.
Per tutto il libro, scritto con uno stile impeccabile e basato su una ricerca meticolosa delle fonti, si respirano un’affinità elettiva e un’identificazione proiettiva da cui non si riesce a prescindere, tra l’autrice e la “sua” Lou.
Un terzo soggetto della scena del libro fa da paesaggio non di sfondo, ma protagonista, come ogni paesaggio di fatto è nelle umane vicende. Quel terzo soggetto è l’epoca, quell’epoca che penetra nelle vite e le esalta o mortifica, o forse fa entrambe le cose. L’epoca che contiene e distrugge, in particolare se le vite sono senza pelle, sensibili oltremodo, esposte e perciò capaci di coglierne e restituirne i tratti più elevati ed elevanti, come ad esempio nella vita di Nadežda Jakovlevna Mandel’štam in L’epoca e i lupi[Mondadori, Milano 1971].
I modi in cui l’epoca informa l’individuazione e plasma le vite si fanno presenti fin dalle parole che Lou Salomé utilizza per scrivere a due figure decisive della sua esistenza, di quella esistenza fatta di incanti che si susseguono senza mai congelarsi in appartenenze definitive. Così Lou, scrivendo a Freud: “In quell’istante a colpirmi, a colpirci, fu la sensazione, la certezza ineluttabile – che si impose senza che Lei l’avesse assolutamente voluto – che la vita umana, o meglio la vita in generale, è poesia. Senza esserne consapevoli noi la viviamo, giorno dopo giorno, pezzetto dopo pezzetto, ma nella sua intangibile interezza essa ci vive e poeta in noi” [p. 22]. E, così, rivolgendosi per lettera a quell’Hendrik Gillot che riconosce come uno degli artefici della propria emancipazione non senza prenderne allo stesso tempo le distanze: “Io non posso vivere secondo un modello, e nemmeno potrò essere mai un modello per chicchessia, ma costruirò la mia vita a mia immagine, e lo farò certamente, costi quel che costi. Con ciò non ho nessun principio da affermare, ma qualcosa di assai più mirabile – qualcosa che sta dentro ognuno di noi e arde di vita ed esulta e vuole uscire” [p. 56].
La tensione vitale di Lou Salomé, uno dei tratti distintivi della sua esistenza protesa a valicare ogni limite, si esprime chiaramente in quella stessa lettera: “Staremo a vedere se la maggior parte dei cosiddetti ‘limiti invalicabili’ che pone il mondo non risultino poi altro che innocui tratti di gesso” [p. 56].
Susanna Mati evidenzia come per Lou Salomé “amare la vita significa – forse in primo luogo – scrivere la vita, sceglierne gli episodi rivelatori e decisivi e, come dichiara, giungere all’essenziale” [p. 17]. Vita e poesia sono indistinguibili: la vita si fa, si crea, (poiesis). In particolare è la seconda vita, quella oltre la vita biologica, che consente l’accesso alla ragion poetica. Poetare la vita vivendola, fin dalla prima gioventù, e fino alla accurata selezione del proprio lascito, consegnando al fuoco tutto quello che secondo Lou della storia della sua vita non avrebbe dovuto far parte, è la chiave della creazione poetica della propria vita straordinaria e paradigmatica, intesa come gioia. Dialogando intensamente con Lou Salomé, Susanna Mati si chiede: “La vita è forse qualcosa di diverso dal racconto che ne facciamo? Come distinguerla, sennò dalla sua pura parabola biologica? Come conservarne, altrimenti, la dimensione fondamentale di gioia?” [p. 19]. Amare la vita, come recita il titolo del libro, è intervenire come autori nella propria esistenza, è praticare un’estetica dell’esistenza. “Come in Nietzsche”, scrive l’autrice, “la vera vita sembra rappresentata dalla sua opera, così in Lou la vera opera sembra rappresentata dalla sua vita; raccontarla è crearla – è la matrice mitologica di ogni autentico esistere: farlo diventare una narrazione di senso” [p. 21]. La collocazione epocale della figura di Lou Salomé avviene nel libro con il ricorso a una categoria di Nietzsche, quella di “buona europea”, in modo da includerla quasi del tutto tra quegli spiriti liberi sovranazionali che rappresentano la punta più avanzata dell’indipendenza e dello sviluppo intellettuale.
C’è in tutta la storia di Lou Salomé, così come Susanna Mati ce la restituisce, l’evidenza vissuta che le idee incapaci di sconvolgere il mondo sono incapaci di smuoverlo. Lou, mantenendo una sfumatura di gioia, o forse solo di edonismo, e praticando quello che potremmo chiamare, con Luigi Pagliarani, un sano egoismo, persegue il piacere della conoscenza, sostenendo “il paradosso di una conoscenza non tragica (ciò, oltre a Nietzsche, lascerà perplesso anche Freud, e in fondo, su un piano diverso, persino Rilke), o, se vogliamo, il paradosso, appunto, di amare la vita” [p. 93]. Sulla figura di Nietzsche, Susanna Mati, che gli ha dedicato tanta parte della sua ricerca, come nell’irrinunciabile Friedrich Nietzsche, [Feltrinelli 2017], giunge in questo libro a una documentata e sottile redde rationem. Il filosofo ne esce radiografato dal punto di vista della sua umana vicenda, e il referto è a tratti imbarazzante, altre volte penoso. O forse tale finisce per apparire in confronto alla determinazione a diventare ed essere sé stessa da parte di Lou Salomé. C’è da dire che questa dinamica che vede la figura di Lou stagliarsi risoluta e inaudita nei confronti degli uomini pur così importanti con cui si confronta e dialoga, non riguarda solo Nietzsche, ma anche lo stesso Gillot, così come Rilke e Freud. Dalla ricerca di Susanna Mati, lo spessore esistenziale di Lou Salomé emerge in quanto connesso ad una speciale modalità di vivere e amare la vita, di elaborare l’angoscia della nascita come “prototipo di ogni angoscia successiva”, di fare i conti con il distacco originario che avviene con la nascita. “La nostra prima esperienza è un’emblematica, improvvisa sottrazione” (scrive Lou Salomé in Lebensrückblick. Grundriss einiger Lebenserinnerungen, trad. it. Sguardo sulla vita. Ricordi, SE, Milano 2017]. “Fino a poco prima eravamo ancora un tutto, indivisi, e indivisibile da noi era quell’Essere cui, inconsapevoli, partecipavamo, quand’è eccoci costretti a nascere, a diventare un minimo frantume di ciò che eravamo”; eppure, anche così dimidiati, secondo Salomé possiamo percepire il “sentimento di partecipazione al Tutto”, il “legame insopprimibile con l’onnipotenza dell’Essere”. Emerge una figura di Lou che crea la propria vita amandola, ad un livello a cui nessuno dei suoi interlocutori mostra di accedere, pur essendo quegli interlocutori sponde importanti della poietica di lei stessa. Amare la vita per Lou non vuol dire solo essere innamorati delle cose belle della vita [“il dolore non vale come obiezione contro la vita”; p. 95]; tutto quello che è parte della vita diviene per lei oggetto di un codice appassionato, un codice affettivo femminile che risulta in buona misura inaccessibile sia al clima culturale del suo tempo, così ben rappresentato dall’ostracismo che la sorella di Nietzsche le riverserà addosso condizionando pesantemente la posizione del fratello, sia ai filosofi, scienziati e poeti suoi interlocutori. Aprire un varco, con la sua esistenza e il suo pensiero, all’affermazione del riconoscimento della complessità dei codici affettivi nella vita e nelle relazioni, è stato un esito tra i più felici e importanti della vita e dell’opera di Lou Salomé.
Si ritrovano nel suo continuo cercare e cercare di nuovo le vie per divenire sé stessa, le basi di quell’evidenza del pluralismo dei codici affettivi che sarebbe divenuto uno dei tratti più importanti dei contributi di Judith Butler. Non solo, ma nella sua esperienza “scandalosa”, nell’immaginazione di sé stessa e persino nella menzogna, come nella scelta da lei voluta di creare la “Trinità”, quella convivenza a tre con Paul Rée e Nietzsche, si propone di contenere amicizia e conoscenza, affettività e giusta distanza, con una modernità incompresa, dove codici affettivi femminili e plurali, dovrebbero, nel suo disegno, essere espressi con esiti emancipativi per tutti. Avremmo verificato in questo nostro tempo quanto sia tuttora difficile, ad esempio, per i maschi non forcludere i propri codici femminili, perdendo così le opportunità che ne possono derivare, pur di mantenere le forme di dominio che tenacemente persistono [U. Morelli, L. Mori, Il codice materno del potere. Autorità, partecipazione democrazia, ETS, Pisa 2013].
Anche quando, come nel caso di Gillot, Lou Salomé, utilizza la parola amore rivolta ad un essere umano, non viene mai meno una distanza, una freddezza, che rimarranno inalterate durante il corso della sua esistenza, vissuta di fatto “senza darsi mai veramente a nessuno”; salvaguardando sempre “la necessità di non legarsi per sempre” [p. 47]. Con puntuale precisione analitica Susanna Mati parla dell’ambiguità dell’emancipazione. Non dell’equivocità né dell’ambivalenza, bensì dell’ambiguità, cioè di quella dimensione irriducibile che nell’esperienza umana distingue tutte le situazioni e le relazioni esistenziali rilevanti, in cui convivono ineliminabilmente vincolo e possibilità, autonomia e dipendenza. Pur nella continua ricerca della convivenza tra spiriti liberi, anche nelle relazioni per lei fondative come nel caso di Malwida von Meysenburg, la vigilanza di Lou riguardo alla propria libertà è una costante della sua vita: “Mi resi allora conto, con mio stupore”, scrive nei Grundriss, “fino a che punto un vagheggiato ideale libertario possa trasformarsi in un ostacolo per l’aspirazione individuale alla libertà”. Anche il triangolo con Rée e Nietzsche finisce per ragioni simili, nel momento in cui i due filosofi propongono inopportune domande di matrimonio e cercano di tirarla ognuno dalla propria parte, “mentre la posizione di Lourimaneva limpida e inattaccabile”, scrive Susanna Mati [p.64]. Di fronte a un simile “egoismo sacro e felino” Nietzsche, quando la loro relazione degrada, le rimprovererà di vivere “per amore di nient’altro che la vita”, e Mati commenta: “Ma possiamo forse amare qualcos’altro?” [p. 91]. Ma qual è allora lo scopo di una vita così vissuta? Consapevolezza e incoscienza sembrano andare di pari passo nel perseguire in ogni età il desiderio di sapere, studiare, imparare, scrivere, poetare; di vivere la vita come conoscenza. Da qui la chiarificazione della falsità del mito della femme fatale, a cui Susanna Mati si dedica con impegno e prove evidenti. Lou va incontro alla vita così com’è, senza pregiudizi e sembra non avere paura di niente, senza mai finire nel sapere tragico, “e anche questa sua forza, questa sua integrità, seduce” [p.115].
Quando nel 1883 iniziano gli anni berlinesi, forse quelli più spensierati della sua esistenza, Lou Salomé ha circa ventidue anni, e il circolo culturale che fonda con Paul Rée diviene uno dei più importanti della città. Sono anche gli anni in cui pubblica il suo primo libro, In lotta per Dio, 1885, un romanzo psicologico in cui fa i conti con il proprio dio costruito nell’infanzia e con quel fulmine dell’incredulità che le cadde nel cuore facendole prendere le distanze dalla religione. A partire da queste considerazioni sulla prima opera, Susanna Mati attraverserà il suo lavoro valorizzandolo nella narrazione del proprio libro, con-fondendone i contenuti con la vita di Lou Salomé. Confermando in tal modo che l’opera vera di Lou è la sua vita, in tutta la sua originale unicità. Ma anche evidenziando, con un taglio critico rigoroso, l’appartenenza di Lou Salomé a quella consolazione metafisica “un po’ semplicistica” [p. 224] che fu propria degli anni della sua formazione, dello spirito di quel tempo. Proprio quella consolazione metafisica non venne mai raggiunta da Rilke e “qui sta tutta la distanza tra i due. Come tra Lou e Nietzsche, come tra Lou e Freud: dispiace doverlo onestamente constatare”. […] “Lou, insomma, rimane affine alle irenistiche filosofie della vita, a quel pensiero di inizio novecento che tenta di ridefinire il Tutto(l’Ungrund) in termini se non metafisici, perlomeno fisiologici; qui si misura la distanza tra il pensiero di Lou e la poesia di Rilke: la prima, volta alla sintesi, all’unione, l’altro al contrario alla consapevolezza della frattura, della separazione; la fiducia di Lounell’unità indistruttibile dell’essere, nell’unione dell’uomo con la realtà cosmica, come dice nelle ultime righe del libro dedicato a Rainer, è un’utopia quanto mai remota dalla consapevolezza del poeta. Tuttavia, se Lou non era una grande artista, né una grande scrittrice, né una grande filosofa, era però colei che tutto comprendeva, che, grazie a un intuito infallibile, scoprì e diede valore a chi rappresentava i più autentici vertici spirituali della sua epoca” [p. 224].
Basterebbe questa citazione per comprendere l’elevato livello di combinazione tra coinvolgimento e distacco con cui Susanna Mati conduce la propria ricerca sulla vita e l’opera di Lou Salomé, rappresentando allo stesso tempo l’essenza della relazione tra lei e Rilke, laddove , quello che è stato il primo amore con coinvolgimento erotico e sessuale, è stato governato da Lou con un distacco che ha preservato l’affettività nel momento della separazione e persino la continuità di una straordinaria relazione col poeta fino alla sua morte. L’attenzione con connotazione autenticamente psicoanalitica che Lou riserva alla creatività del poeta, le consente di estrarre, come evidente nell’ultima lettera che gli scrive, il 12 dicembre 1925, una modernissima teoria dell’arte, peraltro confermata dalle recenti ricerche neuroscientifiche sull’esperienza estetica: “la spinta creativa verso l’opera risulta così intrecciata all’elemento corporeo proprio perché, partendo da questo, stimola a ritornarvi eroticamente riconoscendo l’ultima istanza dell’opera in esso” [p. 227]. Chissà se l’atto di scrivere la sua vita e di farlo, come atto finale, col fuoco, non si possa considerare la sua suprema opera d’arte. LouSalomé, poco prima di morire, ha dato alle fiamme, infatti, buona parte dei suoi archivi, selezionando quale parte della sua storia consegnare ai posteri. Del resto selezionare, sia nel senso di scegliere che di scartare, è sempre stato il suo modo di vivere. Dal mistero del suo matrimonio con Friedrich Carl Andreas, un matrimonio dal quale fin dall’inizio è escluso il sesso, fino alle relazioni con il mondo berlinese, e allo stile di lavoro, inteso come dominio privato, luogo di elezione di una solitudine ambita e autentica, per Lou la vita è incontro. Anche per quanto riguarda la condizione femminile e le tematiche di fondo di questa importante questione, la posizione tenuta da Lou Salomè ha una originalità governata sistematicamente da sé stessa. Nel momento in cui sperimenta una passione come quella con Georg Ledebour, le cose non vanno diversamente; per quanto rilevante, quella relazione sarà accompagnata dall’inquietudine, e soltanto Rilke, di 15 anni più giovane di lei, poté rompere l’incantesimo attraversando quel turbamento, ma sempre fino a quando sarà comunque lei a decidere l’evoluzione e il cambiamento, anche di quella relazione. Per molti aspetti lo stesso amante taciuto, Friedrich Pineles, detto Zemeck, rientra nello stesso stile di relazioni. Nella sua via non dogmatica né adesiva all’emancipazione femminile, le relazioni con le donne, seppur profonde come quella con Frieda von Bülow, non la vedranno mai coinvolta senza il suo peculiare distacco, tranne forse per la relazione con Anna Freud. La stessa adesione alla psicoanalisi sarà un atto individualistico, anti-idealistico e a-morale [p. 166].
Per Lou Salomé, come evidenzia la sua vita e come emerge dal suo rapporto con la psicoanalisi e la sua concezione del femminile e dell’incompiutezza erotica, “ogni amore nella sua essenza è una segreta tragedia, un eterno rimanere estranei in un’eterna vicinanza” [p. 234]. I suoi tanti amori con uomini normalmente più giovani o molto più giovani di lei, uomini con sensibilità femminile, sono caratterizzati da una costante avalutatività, per cui le è pur sempre possibile “scambiare qualsiasi persona con qualsiasi altra” [p. 249]. Secondo Salomé nella vita erotica l’altro è solo una nostra proiezione e l’innamoramento è una forma di autoillusione. Esiste per lei un rapporto stretto tra amore e creatività e l’eros è associato all’arte e alla religione. Nella sua vita, a partire dalla relazione d’amore con Rilke, lei vivrà l’amore in base a questo orientamento. La considerazione della propria vita amorosa è perennemente incompiuta, dall’aspetto erotico, in quanto nessuno come la donna, secondo lei, conosce la limitatezza del rapporto sessuale, alla maternità assente nella sua vita, al matrimonio dove visse una relazione per circa quarant’anni mai consumata, all’aspetto sentimentale in quanto manca nella vita di Salomé il cosiddetto grande amore. Secondo Susanna Mati è l’incontro con la psicoanalisi l’autentica svolta nella vita di Lou, che troverà con Freud l’avventura intellettuale più pregnante della sua ricca esistenza. Lou Salomé la felice, l’indistruttibile, come la definirà Freud, affronta la psicoanalisi dal lato della “gioia di vivere”; lei che aveva da giovane venduto i propri vestiti per comprarsi le opere di Baruch Spinoza, canta un inno alla vita e alla libertà di essere in ogni passaggio della propria vicenda umana. I suoi contributi al pensiero psicoanalitico e la sua intensa pratica terapeutica sono segnati dall’attenzione alla pars costruensdella clinica, essendo in grado di gettare il proprio sguardo nei meandri dell’inconscio senza scorgere niente di unheimlich, di spaesante… anzi, scorgendovi la nostra sicura provenienza e la nostra altrettanto sicura e garantita destinazione da e verso il Tutto, l’Essere, con la libertà dai vincoli del moralismo con cui ha vissuto la propria vita sino alla fine, giungendo a teorizzare l’infedeltà come condizione di libertà e autorealizzazione da parte della donna. La partecipazione attiva alla costruzione e alla ricerca del pensiero e della pratica psicoanalitica, insieme ad una venerazione per Freud e ad una intensa amicizia con Anna Freud, costituiscono un vertice nella vita di Lou Salomé. Nella sua teoria, dove ha espresso contributi significativi, e nella sua pratica analitica, sono importanti i contributi sul narcisismo, anche perché ne era esperta nella vita, e sulle teorie freudiane sull’arte e la religione. L’arte e la religione non sono solo riparatorie, ma attingono come l’eros ad un inconscio che va aldilà della sfera soggettiva, riconnettendosi alla sfera dell’essere primigenio. Hanno a che fare cioè con un elemento creativo assoluto dal quale si esprime la produzione delle opere e la nostra capacità di immaginazione, la sola che ci consente di cogliere il senso ultimo. Bastino le parole di Freud scritte nel suo necrologio del 1937 per la morte di Lou Salomè: con lei si viveva “un’impressione fortissima dell’autenticità e dell’armonia della sua natura”; si “poteva asserire non senza stupore, che tutte le debolezze femminili, e forse la maggior parte delle debolezze umane le erano estranee o erano da lei state superate nel corso dell’esistenza”.
C’è stata un’ansia di fondo nello scrivere di questo libro di Susanna Mati: l’impossibilità di rappresentarne la ricchezzairriducibile, che si può sperimentare solo leggendolo. L’alleanza coinvolta e allo stesso tempo distaccata di Susanna con Lou non lascia indenni, mentre esalta la vita. Immersi nel libro se ne esce in parte cambiati. Il libro Lou Salomé. Amare la vita è un gesto estetico raro, basato su una rigorosa ricerca con cui l’autrice riesce a falsificare i miti consolidati e speciosi, lasciando emergere una figura di studiosa e di antesignana di una particolare e vertiginosa forma di libertà di creare ed essere sé stessa, – e sé stessi per chi voglia ascoltarne la risonanza -, che non conoscevamo.

No Comments